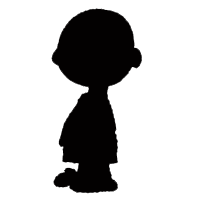
Charlie Brown
"Solo gli imbecilli non hanno dubbi"
"Ne sei sicuro ?"
"Non ho alcun dubbio!"
(Luciano De Crescenzo)
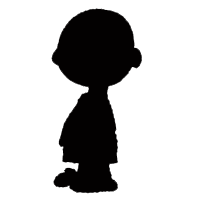
Charlie Brown
"Solo gli imbecilli non hanno dubbi"
"Ne sei sicuro ?"
"Non ho alcun dubbio!"
(Luciano De Crescenzo)
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Notizia dall’ANSA del 20 dicembre 2024.
“Carcere a vita per Costantino Bonaiuti, l’ingegnere che uccise con un colpo di pistola la sua ex, l’avvocata Martina Scialdone, il 13 gennaio 2023 a Roma all’esterno di un ristorante nella zona dell’Appio Latino. Lo hanno deciso i giudici della Corte d’Assise della Capitale accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura che contesta all’imputato anche le aggravanti della premeditazione, dei futili e obietti motivi, del legame affettivo oltre al reato di porto abusivo di arma.
Dopo la sentenza la madre e il fratello della vittima si sono abbracciati piangendo. “È andata come volevamo e speravamo. Timore c’è sempre sui verdetti ma giustizia è stata fatta. Martina non tornerà, una vita è stata spezzata. C’è la sofferenza di tante famiglie, anche quella dell’assassino. Non ci sono vincitori o vinti”, hanno commentato dopo il verdetto.”
Una notizia “giusta”. Sì, ma quanto durerà?, mi sono chiesta dopo averla letta.
È solo il primo grado, la Giustizia italiana prevede due gradi di giudizio: il Tribunale e la Corte d’Appello (in questo caso, Corte d’Assise e Corte d’Assise di Appello). Il terzo, che compete alla Corte di Cassazione, si pronuncia solo per questioni formali che attengono al diritto (corretta interpretazione e applicazione delle norme, vizi nella costituzione e valutazione delle prove, osservanza e uniformità della legge nazionale e altre competenze relative alla giurisdizione), non più sul merito, che ha già avuto due strumenti di esamina da parte dei giudici. Ergo, vi è possibilità che si proceda per il secondo grado di giudizio.
Siccome non sempre le sentenze di secondo grado confermano le motivazioni di fatto e di diritto contenute nelle sentenze appellate (sentenze di primo grado), vi è il rischio che qualora si dovesse avanzare domanda di appello, la sentenza di primo grado della Corte d’Assise potrebbe essere riformulata in toto o in parte (quest’ultima ipotesi resta la più probabile). Se ciò dovesse avvenire, che fine fa la giustizia?
Martina l’ho conosciuta. Per un periodo ci ho lavorato. Abbiamo condiviso le stesse stanze, lo stesso lavoro, le stesse aule di Tribunale che le hanno reso giustizia e che mai, la sottoscritta e le persone che lavoravano a contatto con Martina e la scrivente, avrebbero immaginato di averci a che fare direttamente, faccia a faccia. Quelle aule si frequentavano per far valere i diritti dei propri clienti. Eravamo strumenti, mediatori, mandatari, delegati, pacieri (ci provavamo, sino ai limiti del possibile), non vittime. Non lo siamo mai stati, e nemmeno ci sognavamo di esserlo. Poi, come sempre accade nella vita, succede quello che non deve succedere (nella buona e nella cattiva sorte).
La notizia della sua uccisione è stata una doccia gelata, uno shock, un incubo, un’onta, una macchia puzzolente e scura. Non ci potevo credere, non ci credevo. Il mostro, lo scarafaggio, lo “avevamo” in casa. Era accanto a Martina, e quindi era accanto a noi. Respirava l’aria di Martina, e quindi infestava la nostra aria. Si nutriva della vitalità, della spensieratezza, dei sogni di Martina e quindi si nutriva delle nostre speranze di costruire e avere un mondo migliore.
Non sono un giudice, non lo sono mai stata e non voglio esserlo. La carriera di giudice e medico sono le carriere più ambite perché permettono di elevarsi ad un alto rango sociale, di darsi una certa importanza, potere, rispetto, lustro, ricchezza… uno non pensa mai che sono mestieri di grossa, grandissima responsabilità. Sono ruoli che vanno assunti con coraggio, determinazione e cuore, molto cuore, perché c’è in ballo la vita delle persone. Non è il caso di farne una questione di leggerezza relativa solo all’immagine e al prestigio, perché prestigio e immagine sono le ultimissime cose da tenere in considerazione in questi lavori. Prima vengono le persone.
E qui il discorso si fa lungo.
Perché chi è che può dire ciò che è giusto e ciò che non è giusto? Sì, Giustizia è stata fatta. Martina ha visto riconosciuto il suo diritto, la sua giustizia. Non mi sento di approfondire l’argomento. È giusto così, quell’omicida andava fermato e condannato. Ma per qualcun altro potrebbe non essere così, e quindi la sentenza va appellata.
Adesso, consideriamo per un momento questa assurda ipotesi, i giudici della Corte d’Assise d’Appello come si muoveranno? Confermeranno la sentenza (e quindi carcere a vita) oppure la rimoduleranno (sconto o commutazione di pena)? E se la riformeranno, dove va a finire la giustizia, cosa si può chiamare giustizia?
Stamattina ho fatto questa riflessione: le favole e la giustizia sono due concetti molto relativi, perché uno se le aggiusta e se le racconta come gli pare.
Riflettete: la giustizia non è sempre giusta. È imperfetta. Sono gli uomini a fare la giustizia, ad interpretarla (l’interpretazione è sempre soggettiva, mai oggettiva), ad applicarla. E se l’uomo per natura è imperfetto, tutto ciò che discende da lui è imperfetto. Sintesi: la giustizia me la costruisco e la utilizzo come mi pare, facendola passare per cosa buona e giusta ma, sotto sotto, è frutto di mia invenzione, opinione e pensiero.
Reminiscenza. In gioventù (è ilare l’espressione e voglio vedere in quanti se ne accorgono) ho lavorato per diversi studi legali dove venivo corretta e redarguita per la forma che utilizzavo nella stesura degli atti. Un giorno una titolare dello studio mi fa: “non utilizzare sempre la stessa terminologia, soprattutto quando riporti le massime della Cassazione”, “Vabbè ma come faccio a sottoporre all’attenzione del giudice questo particolare aspetto attraverso la statuizione della Cassazione?” le chiedo. “Puoi sempre scrivere la Cassazione asserisce, definisce, opina…” (scrivevo sempre «statuisce» quando tiravo in ballo la Suprema Corte). Il verbo «opinare» mi piaceva, e da quel momento in poi iniziai a farne largo uso, sennonché, quando arrivò l’occasione di cambiare studio il titolare (un tipo molto pignolo) mi fece notare questa cosa e, piuttosto alterato, mi rimproverò dicendomi: “Ma come ti viene in mente di scrivere che la Cassazione opina? Adesso i giudici si mettono a dare opinioni?”. Il risultato fu che non mi avvalsi mai più del verbo opinare, ma oggi mi sento di dire che, tutto sommato, non era sbagliato usarlo. Certo, poteva sembrare offensivo citare la Suprema Corte di Cassazione depauperandola della sua capacità di giudizio scrivendo che opinava invece di statuire, chiarire, ribadire, stabilire, eccetera ma, in sostanza (e per logica) non ero lontana dalla verità.
Stesso tipo di ragionamento vale per le favole. Io me le sòno, me le canto e me le racconto quando non ho più voglia di assistere al cesso di realtà che mi circonda, dalla delusione, dalla tristezza e dalla frustrazione che mi accompagnano nel corso delle giornate e dal senso di solitudine che non mi si scrolla di dosso quando vado a coricarmi la notte. Allora per non pensare, per non sprofondare, per non avvilirmi (e avvizzirmi) mi invento un mondo nuovo, una nuova vita, una nuova realtà: più bella, più allegra, più giocosa, dove si resta per sempre bambini.
Nd sit bell!¹
In fondo le cose belle della vita servono a questo: porre rimedio al male, alla bruttezza. Poco importa se poi la cattiveria, il brutto, continuano ad esistere (e si fa troppo poco per debellarlo).
Si parla. Si parla soltanto (non si discute, perché nella discussione è insita la dialettica, il confronto, l’ascolto). Parole, parole, parole/Parole, parole, parole/Parole, parole, parole/Parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi…
Poi quando e se si fa, si viene pure criticato, giudicato e in alcuni casi pure attaccato. Tutti molto coerenti, soprattutto se il giorno prima scendevate in piazza a manifestare contro il femminicidio e ora vi battete per una certa censura al diritto di espressione.
Pure io voglio esprimermi alla mia maniera: se faccio un peto per strada verrò censurata per il mio modo di esprimermi? È la mia arte, un modo di pensare e manifestare. Eccentrica, ma pur sempre un’arte (perché poi mi dovete spiegare cos’è l’arte se nella definizione vogliamo far comprendere ogni e qualsiasi libertà di pensiero, anche se è contro la morale e contro ogni principio di eguaglianza e rispetto di cui ci riempiamo le bocche ogni giorno e ci sentiamo in diritto di manifestare per difenderli).
Non voglio tirarla per le lunghe, pure perché si è già discusso tanto sull’argomento e chi scrive ha già detto la sua sulla coerenza, sulla verità e sulla responsabilità di cui è investito un personaggio pubblico.
Un’ultima cosa però la voglio dire, riassumendola con una massima che non ha bisogno di esegesi (il lemma non c’entra nulla con la massima, ma è modo ironico di servirsene visto che si è dissertato di “diritto” e “giustizia”), ma che lascia trarre a voi le conclusioni: campano tutti, chi più chi meno, sulla stupidità umana (Luciano De Crescenzo).
¹Quanto siete belli!
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Famiglia di Tommaso Medugno ²
Non è facile dirvi quanto sto per dirvi. No, non è per niente facile.
Ho scoperto di avere una malattia, grave, e a quanto pare anche cronica e non curabile.
Ho la prosopagnosia¹.
Le prime avvisaglie le ho avute un anno fa, mese più mese meno. Un piccolo disturbo ma, proprio perché era un disturbo, mi ha dato molto fastidio perché ha dis-turbato la mia giornata (dal latino disturbare, composto dal prefisso dis e dal verbo turbare: disperdere. Disperdere, sempre dal latino: disperdo, disperdis, disperdĭdi, dispersum, disperdĕre: dissipare, mandare in rovina).
Nonostante la cosa mi stesse scombussolando, decisi comunque di non darle peso. Una reazione comune a tutte le malattie, uno status psicologico che serve da scudo ad ognuno di noi: cancellare il male, far finta di non vederlo o di non sentirlo per scongiurare il rischio che prenda il sopravvento sulla paura (una banale difesa per esorcizzarla).
Accade poi che “il fattaccio” si ripresenta, e a quel punto comincio ad essere assalita dai dubbi.
Per dovere di completezza aggiungo che soffro di un’altra malattia – forse pure peggiore della prima – che è “la giustifica”, cioè la tendenza a giustificare sempre e nonostante tutto chi ho dall’altra parte.
Dove vuoi arrivare? Domanda che vi starete ponendo.
Ora ve lo dico, ci proverò, è molto complesso come discorso e non vi piacerà.
Molti di voi ricorderanno la querelle che c’era stata riguardo alla nomina di Luca De Fusco come Direttore della Fondazione Teatro di Roma che amministra e gestisce quattro tra i più importanti teatri della Capitale: il Teatro Argentina, il Teatro India, Il Teatro Torlonia e il Teatro Valle “Franca Valeri”. A suo tempo, questa nomina avvenne in maniera non proprio regolare per via – come ormai succede spesso, purtroppo, in tutte le questioni – di un’ingerenza dell’attuale Governo che spingeva per il nome di De Fusco su una rosa di 40 candidati a copertura del ruolo.
Senza entrare troppo nel merito (altrimenti ci dilungheremmo su un discorso prettamente politico perché, in sostanza, fu questo il nocciolo dello “scontro”, ridurre il tutto ad una questione politica perdendo di vista quello che era ed è il tema fondamentale, ossia continuare a garantire l’esistenza e la possibilità da parte dell’utenza di usufruire del più grosso polo culturale ed intellettuale della città) il punto fu questo: la nomina di De Fusco avvenne scavalcando decisioni e figure che nel CDA erano necessarie per la sua approvazione.
Di fronte a questa situazione scorretta un folto numero di attori, giornalisti, registi, uffici stampa, scrittori, di orientamento politico opposto al Governo, insorsero con lettere, proteste, petizioni e sit-in davanti al Teatro Argentina. Tra questi artisti c’erano persone che il pubblico conosce e che, nel corso degli anni, ha imparato ad apprezzarne le doti. Il talento, però, non è l’unico aspetto per cui vengono apprezzati e seguiti; vengono apprezzati anche per il loro modo di essere, di pensare, di porsi e di dire determinate cose.
Se a me piace un artista è perché con quell’artista mi trovo a condividere molto del suo modo di pensare, e perché trovo che con me ha molte affinità quasi come se fosse il mio specchio. Non è un caso quando, infatti, ci troviamo a parlare con qualcuno e gli diciamo: «Mi piace il tuo modo di vedere le cose perché rispecchia molto quanto penso sull’argomento», ragion per cui abbiamo anche piacere a frequentarlo.
Gli artisti – e quando dico “artisti” la definizione è da ritenersi estensiva che comprende attori, scrittori, cantanti, presentatori, comici, ballerini, registi, sceneggiatori, autori, compositori, eccetera – sono persone. E con le persone, anche quando non vuoi, si arriva a un punto di rottura. Soprattutto quando vieni preso in giro.
Poco prima accennavo dicendo che questo sarebbe stato un discorso molto complesso, specialmente non gradevole perché, disquisendo sul tema, dobbiamo prendere in considerazione una componente oggettiva e una componente soggettiva.
La componente oggettiva tira in ballo due aspetti essenziali che, ad avviso di chi scrive, sono di elevata importanza nella sfera di un individuo e nelle sue relazioni sociali: verità e coerenza.
La componente soggettiva assume connotati più dolorosi perché va ad incidere nella sfera più intima, più empatica e più sensibile della persona, che è la parte emotiva. Per componente soggettiva non mi riferisco solo alla sensibilità dell’utente, ma anche alla sensibilità del suo beniamino che si trova ad avere una grossa responsabilità nei suoi confronti e a metterci la faccia in tutto quello che fa e che dice.
Poco gradevole perché la verità non piace a nessuno. Tutti la pretendiamo, tutti la inneggiamo tanto quanto, al contrario, tutti la scansano e se l’acquattano, come se dice a Roma (perdonate lo slang ma vi parlo come si parla a un amico senza giri di parole, più comunemente conosciuta come la lingua del parla come magni).
E veniamo al cuore dell’argomento.
Superato, alla bell’e meglio, il patatrac della nomina di De Fusco – per chi non lo sapesse comunque, dunque e dovunque, è lui che dirige la Fondazione Teatro di Roma – un bel giorno mi alzo, prendo il caffè, scorro le notizie dell’ultim’ora e do un’occhiata alla stagione teatrale 2024/2025 del Teatro di Roma. Cosa scopro secondo voi?
Che una delle firme dei dissenzienti alla nomina di De Fusco al ruolo di direttore è in cartellone.
Immaginate il mio stupore. La sorpresa (dell’ovetto kinder) è tanto brutta in quanto avevo una grande considerazione, nonché una grande ammirazione, per l’artista (che ho stolkerato per tutti i teatri d’Italia).
Occhio: in questo caso è un personaggio dello spettacolo ma queste “belle sorprese”, come dicevo poc’anzi, mi sono capitate e continuano a capitarmi con tantissimi altri artisti appartenenti ad altre categorie, tanto da crearmi una frattura grossa quanto villa Arcore, villa Briatore, villa Clooney, villa Pitt, villa Stallone e villa Totti tutte messe assieme.
È solo un esempio – o un dettaglio – ve ne potrei citare altri. Ma c’è un problema: non mi piace parlare male delle persone, non mi piace parlare male degli assenti (oddio, assenti… state tutto il giorno a chatta’ sui social, poi me lo spiegate come funzionano ‘sti aggeggi perché io non l’ho ancora capito), non mi piace parlar male delle persone in cui credo. Non mi piace parlare male del vicino, perché quel vicino potrei essere io.
Ok, sono imperfetta. Ho sbagliato. Ma nessuno dice: “Ho sbagliato”. Vorrei sentirlo dire ogni tanto, come lo dico io: «ho sbagliato».
Vorrei smettere di vedervi andare in giro per programmi, eventi, concerti, manifestazioni, festival, social (pe’ fratte, pure pe’ fratte perché c’annate pe’ fratte, e pure pe’ frappe perché bisogna pur nutrirsi), premi, conferenze stampa, congressi, università, cartelloni, talk show, meme show, fiere, per sentirvi dire quanto siete bravi, quanto siete belli, quanto siete boni, quanto siete grandi.
Vorrei che la smetteste di usare belle parole solo per magnificare il vostro ego, e che faceste qualcosa di più concreto, qualcosa che si vede, che dà valore, che dà vita, che dà senso a ciò che fate.
Vanno bene i concerti di beneficenza (dove finisce poi tutto il denaro raccolto resterà il Mister assoluto dei misteri), ma che non si fermi qui il vostro operato, vanno bene le manifestazioni in piazza per la lotta alla parità di genere, per dire stop al femminicidio, per dire no al precariato, per il riconoscimento del diritto all’eutanasia, all’aborto, alla sicurezza, alla salute… va bene anche parlare per sensibilizzare l’opinione pubblica, ma il pensiero non si deve fermare alla parola altrimenti sono solo belle parole e basta, che servono come maschere per ingannare la gente e passare per persone fighe e perbene.
Da diversi mesi il nostro Paese è preda delle alluvioni per le violenti piogge. Invece di riempirvi le bocche con frasi a sostegno della solidarietà sui social e sui media, perché non andate a dare una mano alla povera gente a spalare il fango con le pale, i secchi, le sacche? Perché non vi recate nelle periferie delle città, nelle carceri, nei centri di recupero, per ascoltare le storie degli adolescenti e delle famiglie difficili e cercare di trovare insieme una soluzione per attenuare il problema della criminalità? Perché quando c’è da testimoniare un torto, salvare un canile, aiutare dando davvero da mangiare a un indigente vi voltate dall’altra parte? Perché non vi sporcate?
C’è un editore, un giovane editore, che è anche scrittore. Si chiama Nicola Pesce. La sua pagina Facebook conta più di 230mila followers (toh, visto che vi piacciono così tanto i social vi do un po’ di numeri, numeri buoni). È una delle esigue persone che merita veramente di essere seguito.
Lui non parla soltanto. Lui fa. Lui crede e si impegna in quello che fa. Caccia fuori i soldi di tasca sua, non li rincorre, non è interessato al denaro. Non è interessato alla fama. Non si concentra su se stesso. È aperto al mondo, alla natura, agli animali. Coltiva gentilezza, cura e attenzioni. Ascolta. Dà importanza alle persone perché vuol bene e ci tiene alle persone. Le rispetta.
Sono dettagli, ma i dettagli dicono molto di chi ci sta di fronte. I dettagli contano tantissimo perché sono gli unici strumenti che dicono la verità. Può essere un tono di voce, un’espressione del volto, un gesto, un colore, una frase, una parola.
Prestate
Attenzione
Ai
Dettagli.
Non sempre vanno di pari passo con la forma.
Non sono nessuno per dirvi come dovete comportarvi, e chiedo umilmente perdono a chi si è sentito chiamato in causa per essere stato “oggetto” di biasimo. Ho usato parole dure, me ne dispiaccio. Conosco il loro peso e la loro forza, so quanto possano far male.
Resta il fatto che se, casomai, dovesse capitare di incontrarci e non vi riconosco non è perché sono diventata pazza (quello è normale) o tutt’a un tratto maleducata. Sono malata, sono molto malata.
Ho la prosopagnosia.
¹Prosopagnosia, dal greco: πρόσωπον (“prosopon” faccia) e ἀγνωσία (agnosìa, non conoscenza, ignoranza)
² La foto a corredo compare sulla copertina del libro di Raymond Carver, Da dove sto chiamando e altri racconti edito da Minimumfax, edizione 2003.
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Nutro una profonda urticaria per i romanzi rosa. Chiariamolo: non c’è nulla di male ad essere romantici, ma con moderazione (come in tutte le cose).
Quando ero una adolescente il genere letterario da me prevalentemente letto era il genere rosa. Poi sono guarita, ma sono stata condizionata per un bel po’ di tempo. La ragione – non mi piace definirla colpa – è ascrivibile a mia nonna, la quale era molto affezionata alle favole di principi e principesse che la portavano ad essere una romanticona. O forse era il contrario. Le piacevano le favole perché era lei ad essere romantica. Vabbè, fatto sta che aver trascorso molto tempo con lei durante la mia infanzia ha comportato una crescita esponenziale della mia immaginazione. Non era possibile che il “mondo fuori” fosse diverso dal “mondo fantasticato”, ma soprattutto che il primo fosse molto cattivo.
Ascoltandola mentre mi raccontava le sue favole mi convincevo sempre di più che da qualche parte, al di là di quelle mura domestiche, ci fosse il Principe Azzurro ad attendermi. Dovevamo solo pazientare: lui doveva essere bravo ad aspettare che io crescessi, e io altrettanto brava ad aspettare che crescessi per poterlo incontrare.
Quella bambina poi è cresciuta e, con grande rammarico, ha scoperto che il mondo fuori non era affatto uguale al mondo fantastico dove la nonna la accompagnava quasi tutti i giorni per fare dei bellissimi e indimenticabili viaggi, e ci è rimasta male. Non sa se prendersela con quella nonna che l’aveva tanto amata, si sente un po’ ingannata. Poi conta fino a dieci, sospende il giudizio (epoché, dal greco έποχή, “sospensione”) sulla dolce e tenerissima donna anziana e arriva alla conclusione che la nonna non ha nessuna colpa. L’unica colpa che ha è quella di averla amata tantissimo. E quando si ama tanto capita di cadere vittima dell’errore.
Dalle favole siamo passate alle telenovele, e dalle telenovele ai romanzi d’amore.
A proposito di telenovele, ricordo ancora come fosse ieri che un pomeriggio costrinse me e le mie amichette a guardare assieme a lei l’ultima puntata di Topazio; lei era seduta sulla sua solita sdraio dietro di noi, e noi sedute a terra a gambe incrociate, in fila per due (era estate), tutte concentrate manco stessimo guardando Sanremo. Nelle sue intenzioni – e in particolar modo, per un maggiore senso di sicurezza dei nostri genitori – era meglio che fossimo tenute sotto la stretta sorveglianza del suo occhio vigile piuttosto che scorrazzare in giro per le strade e i vicoli del quartiere dove eravamo solite giocare all’aria aperta a nascondino, a campana, a un, due, tre, stella e via dicendo.
Per quanto riguarda i romanzi rosa (che lessi fino ai primissimi anni di università poi, come facevo notare, uscii dal coma) non menziono le autrici. Il perché lo scoprirete leggendo.
Nel corso degli anni ho collaborato con diverse testate giornalistiche cartacee e online. Tra le tante c’è quella con Leggere:Tutti, rivista di libri e letteratura. Ergo, un po’ per la mia patologia/dipendenza legata ai libri, un po’ per l’onere (e l’onore) di assolvere al compito di cercare spunti interessanti per stendere gli articoli, mi viene naturale curiosare tra gli argomenti che stuzzicano la mia attenzione.
Succede questo. Circa una dozzina di anni orsono mi capita di leggere un’intervista di una giornalista inglese in cui analizzava con una psicologa (che era anche autrice di libri) i pro e i contro dei romanzi rosa. La conclusione a cui si giunse era questa: questo genere di lettura fa più male che bene perché, in sostanza, illude le lettrici. Inutile dire che il tema aveva destato il mio interesse perché quanto affermato dall’autrice collimava con le mie stesse considerazioni. Coincidenza vuole che dopo pochi giorni mi trovo a seguire la presentazione del libro di un’autrice di romanzi “romance” in una libreria di Roma. Al termine, chiedo alla referente della penna – impegnata ad elargire autografi alle sue affezionatissime e numerose lettrici – se è possibile avere il suo contatto per poter svolgere un’intervista dato che in quel momento risultava impossibile interloquire di persona stante l’ora, l’impegno e la stanchezza profusa per le sue fan giulive. Lo ottengo, e quando mi accingo a predisporre le domande non riesco a trattenermi dall’infilare una provocazione che assomiglia molto a quella della giornalista inglese, solo posta con più garbo.
La destinataria, all’atto della ricezione, non la prende bene. Non mi insulta, ma dal tenore della risposta capisco che era suo desiderio farlo perché è piuttosto stizzita. Incasso la reiezione dell’intervista e tutto finisce lì. Tuttavia, seppur consapevole che la domanda pruriginosa l’avrebbe infastidita speravo nel colpo di scena, e cioè che alla mia provocazione rispondesse con la stessa provocazione, oppure zittendomi con una risposta arguta.
Non ho più avuto occasione di incontrare l’autrice (che ha sempre avuto un enorme riscontro di pubblico e continua ad averlo).
2024. Notizia di quattro/cinque mesi fa. Su uno dei più noti quotidiani italiani la famosa autrice, in una intervista, confessa lei stessa di scrivere “ciofeche”. Adopera proprio questa parola: ciofeca. Per chi non lo sapesse, “ciofeca” o “ciufeca” è, secondo l’enciclopedia Treccani, un etimo incerto, probabilmente di origine spagnola (dal termine chufa) che indica una mandorla amara per fare un’orzata; il nome invece deriverebbe dall’arabo safek e sta a significare una bevanda (vino o caffè) di pessimo sapore, broda, porcheria, schifezza. Non proprio una definizione di tutto rispetto, insomma.
Sorrido divertita. Non so se è l’età che dà maggiore consapevolezza ad un individuo o se al tempo la beccai in un momento poco adatto, comunque sia la prima cosa che penso è: “E io che ti ho chiesto tanti anni fa?”. Certo, non le domandai: “Carissima Signora, è vera questa cosa che i romanzi rosa fanno cagare, non sono utili a nessuno e, pertanto, visto che fa parte della cerchia degli autori romance anche ciò che scrive lei è da reputarsi come una vera e propria schifezza?”.
Nulla, nulla di tutto ciò. Mi limitai solo a domandarle se era d’accordo con le conclusioni giunte all’analisi dell’intervistatrice e della psicologa riguardo al genere letterario rosa (le avevo accennato a quell’articolo che lessi), e quali erano le sue opinioni al riguardo.
A distanza di anni non solo scopro che, in fondo in fondo, la mia non era una domanda sbagliata, ma qui (o all’epoca in cui si svolsero i fatti) se c’è qualcuno che “offende” o “aveva offeso”, quel qualcuno non fu la sottoscritta, anzi. Chi parla del proprio lavoro usando una terminologia dispregiativa è lo stesso soggetto che si sentì offesa. Affermare di scrivere ciofeche è come ammettere di essere un’autrice veramente scarsa.
Vorrei fare un appunto. Ho scritto “non so se al tempo la beccai in un momento poco adatto” perché è vero che la beccai, nel senso letterale del termine. Sebbene posi la domanda in modo educato, era tutto sommato una provocazione. In pratica è come chiedere ad un autore di gialli “ma perché scrive di morti ammazzati quando già siamo circondati da una cattiveria infinita? Non crede che così facendo contribuisce ad aumentare il tasso di criminalità?”, che può essere recepita come un’offesa, chiamiamola così, oppure un’accusa.
C’è una differenza tra le due cose, una grossa differenza. I detrattori reputeranno una apologia a favore dei giallisti quanto sto per dire.
Gli assassini esistono. I mostri esistono. Le vittime esistono. È un horror, un incubo a cui assistiamo tutti i santi giorni. Siamo bombardati dalla cronaca nera. Ci abbuffano di omicidi, violenze, stupri, risse, furti, minacce. La cosa assurda – e preoccupante – è che queste perversioni non ci vengono mai a nausea, sia da parte di chi li commette, sia da parte dello spettatore che gode dello spettacolo della morte. Siamo un popolo di ingordi della morte e della violenza.
Il Principe Azzurro, invece, non esiste. Ci abituano e ci insegnano a crescere convincendoci del contrario. Quello che dovremmo imparare, su cui dovremmo allenarci ed esercitarci è la capacità di discernimento: comprendere ciò che è favola, da ciò che favola non è. Basta illusione, basta evasione. Se c’è qualcosa da cui evadere sono gli stereotipi.
I libri, l’arte, la scienza, la matematica, la filosofia, i viaggi, le lingue, la cultura servono a questo. Ad apprendere, imparare, a crescere e a migliorare.
*Il titolo si riferisce alla trama del thriller di Donato Carrisi, La casa dei silenzi di ultimissima pubblicazione con la Longanesi Editore. Lo “scarafaggio” è un essere molto pericoloso che, il più delle volte, si stenta a riconoscere perché è bravissimo a mascherarsi e ad assumere l'aspetto di “salvatore”.
Accedi o Registrati per commentare l'articolo