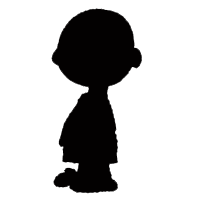
Charlie Brown
"Solo gli imbecilli non hanno dubbi"
"Ne sei sicuro ?"
"Non ho alcun dubbio!"
(Luciano De Crescenzo)
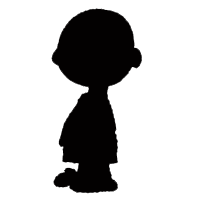
Charlie Brown
"Solo gli imbecilli non hanno dubbi"
"Ne sei sicuro ?"
"Non ho alcun dubbio!"
(Luciano De Crescenzo)
Lo scrittore è un animale che tante volte è puro ma in qualche modo vuole la fama, costantemente, per quanto micidiale essa possa essere, perché anche gli scrittori sono contagiati dal virus dell’eternità. Amano le parole e vogliono produrre opere per cui ciò che è oscuro venga alla luce, ma vogliono anche che quelle parole durino per sempre. E così, tristemente, lo scrittore è quell’animale che confonde la fama con l’amore.
La massima che precede – tratta dal romanzo Il futuro futuro di Adam Thirlwell – ha destato nella sottoscritta una vecchia reminiscenza, solleticata da un’altra massima letta in un altro libro, che aveva come tema l’eternità.
L’apoftegma recitava così.
“Ci sono tre modi per ottenere l’immortalità: piantare un albero, fare un figlio, scrivere un libro”. Sono le tre possibilità messe a disposizione di un individuo per lasciare una traccia di sé nel mondo.
Non so quante sono (se ci sono) le persone che si assumono l’impegno di piantare un albero, prendersene cura e vederlo crescere. Non mi va neanche di approfondire la questione perché trovo che questi precetti recano con sé qualcosa di tragico nel profondo della loro essenza.
L’unica riflessione che mi sento di fare è che tra le tre opzioni sopra prospettate quelle verso cui la gente è più attratta sono le ultime due. Con esiti disastrosi, permettetemi di aggiungere.
Procreare è biologicamente naturale, non so dire neanche se è una scelta o no. Qualsiasi essere ha il potere di generare una vita, sia che sia voluta sia che non sia voluta, a meno che non si soffra di qualche forma di sterilità o altra patologia che ne ostacoli la riproduzione. Lasciamo perdere la seconda alternativa e concentriamoci sulla prima.
Chi sceglie di generare una vita lo fa per amore (si spera). Nell’istante in cui il seme si innesta per far germogliare il frutto del sentimento che unisce due esseri, questo frutto recherà per sempre con sé una parte dell’uno e dell’altra ereditandone capricci, difetti, pregi, vizi o deformazioni che, in un altro corpo diverso dal feto, hanno determinato il carattere e l’identità di un individuo. Magari uno, preso dalla passione che sta vivendo in quel momento, non pensa neanche che nell’atto di moltiplicarsi sta in realtà plasmando la propria immortalità – un po’ come faceva Voldemort, il mago cattivo della saga di Harry Potter che divise la propria anima depositandola in sette horcrux per assicurarsi la vita eterna – o forse sì, ragion per cui si figlia non più per amore ma per “cristallizzarsi” in un altro essere umano (amore o egoismo, dunque?).
La cosa che più temiamo è quella di venire dimenticati. Per non aver vissuto invano, per dare eco del nostro passaggio nel mare magnum dell’esistenza, dobbiamo dire o fare qualcosa perché gli altri si ricordino di noi. Non basta diventare miliardari, il denaro conta ma non è sufficiente. Il denaro non dà l’Eternità.
Il detto “i soldi non fanno felicità” è veritiero. C’è tanta gente che naviga nell’oro, non tutti ma la metà di essa è depressa o insoddisfatta. Si illudono di avere tutto, ma non hanno nulla. Loro questo lo sanno, ma non sono in grado di ammetterlo con se stessi. Credono di averla vinta sul tempo e sui loro limiti con la chirurgia estetica, ma anche questa è un’illusione.
Si attraversa la vita come si attraversa una strada o un incrocio. E sono le scelte a determinarti, aggiungerete voi. Beh, forse avete ragione. O forse no. Chi può dirlo? Per chi crede nel destino le scelte non servono perché il libro è già bello scritto, pubblicato, editato e impacchettato. Diversamente, le scelte contano eccome.
Se è tutto un attraversare sono io (individuo) a decidere quale percorso seguire. Se decido di percorrere un itinerario, quel tipo di tragitto avrà una sua mappatura con i suoi incroci e le sue strade; al contrario, se decido di dirigermi verso tutt’altra direzione su quel cammino sorgeranno altri vicoli e intersezioni. Così se scelgo un terzo percorso, un quarto e così via. Il problema resta sempre lo stesso: non posso attraversare solo perché bisogna attraversare, ma devo lasciare le mie impronta.
Nel nostro quotidiano, modesto parere di chi scrive, di orme ce ne sono fin troppe.
Non serve più piantare alberi o fare figli (questi ultimi sono diventati pure una seccatura, oltre che un grosso onere economico). Basta scrivere, e non necessariamente libri.
Guardatevi intorno: quante persone conoscete che scrivono? Anche baggianate, ma scrivono? La vita vera non è più uscire di casa per lavorare, fare la spesa, mangiare una pizza, andare in palestra, fare una chiacchierata al parco, passeggiare all’ara aperta, imboscarsi… (pure imboscarsi sì, che c’è di male? Pure dasse un appuntamento in un tugurio di ostello, vedesse dietro a una quercia o per cinque minuti alla stazione pe’ ‘n saluto veloce o un bacetto).
Ora, dico io, perché tutta ‘sta necessità di pubblicare un libro? Perché sprecare carta, abbattere gli alberi (magari state ammazzando un vostro antenato piantato mille e mille anni fa e manco lo sapete), inquinare il pianeta (chissà per quanto tempo ancora dobbiamo campare…ah già, a voi non interessa l’argomento…voi andate in cerca dell’immortalità!), insomma… perché dobbiamo darci fastidio più di quanto non lo stiamo già facendo sugli smartphone, sui tablet e sui pc? Basta dar voce alle proprie esigenze e insoddisfazioni con lo strumento che ci è stato concesso per conseguire il nostro scopo: i social.
Ma non è la stessa cosa di un libro…! che differenza c’è? Un oggetto dà più successo di un mezzo che ti mette a disposizione pure la scorciatoia per arrivare prima alla vetta? Ok, coi libri vai in televisione, alla radio, puoi rilasciare tantissime interviste e magari immillare il numero dei like sul tuo profilo social… insomma raggiungi il tanto agognato successo! Finalmente c’è gente che parla di te, che si accorge di te, sa che esisti, che sei bravo, sei ballo, hai talento, qualità… sei immortale. Ma siamo sicuri?
Non sono a conoscenza del momento storico in cui quella chiosa fu vergata su carta, non sono neanche sicura se la massima è dell’autore che avevo letto anni fa, o se sono io ad attribuirgliene la paternità (se così fosse, sarebbe la primissima volta che mi trovo a dover dissentire con lui) pur appartenendo ad un altro autore; quel che è assodato è che oggi l’apoftegma è anacronistico.
Oggi tutti scrivono, ognuno di noi lascia una traccia di sé. Ai tempi del mio autore si scriveva sul diario segreto, su pezzi di carta di un block notes nascosti nel cassetto di un comodino (magari infrattati tra le mutande multicolor, di pizzo o della nonna non ha importanza tanto nessuno ci andava a ravanare là dentro), nei libri di scuola, in fondo allo zaino o nella roba conservata negli scatoloni su in soffitta… l’alea di finire nel dimenticatoio era molto concreta.
Pure oggi si finisce nel dimenticatoio, se non ti dai da fare e non fai qualcosa per farti notare. Ecco perché stiamo lì a sgomitare nei post, nei commenti, nelle “opinioni”, nei reels (ma che so’? Come si usano?); siamo come dei caproni impazziti, sembra non ci sia abbastanza spazio per tutti e dobbiamo lottare per conservare il nostro posto e, se possibile, usurpare pure quello dell’altro fino ad annientarlo.
Siamo l’uno l’invasore dell’altro… Combattiamo per conquistare confini (consensi, like, cuoricini di Coma_Cose), per “allargarci”; più ci si espande più si acquista potere, fama, nome, prestigio. I posteri si ricorderanno di tutta questa grandezza, diverrò Immortale. A quale prezzo?
(Ma nu ve basta ‘o schifo che fate, c’avete bisogno de replicarlo ‘sto schifo e portasselo avanti nei secoli?)
Poc’anzi accennavo ai risultati disastrosi di questi metodi per diventare immortali.
Per quanto concerne la prima opzione (fare figli), in tutta sincerità, mi sento di ringraziarvi per il contributo che date affinché la curva demografica delle nascite si assesti sulle percentuali basse delle statistiche. Grazie anche al Governo² che con le sue politiche ci assicura che questo status quo perduri nel tempo (che guaiacchione!³ direbbe la mia cara prof di filosofia, mamma mia e com stam nguaiat!³).
Scherzi a parte, mettere al mondo un bambino solo per “fare famiglia”, o perché “lo fanno tutti”, o “Ieri vi siete sposati? Ma dai… non lo sapevamo…e quando lo fate un figlio?”, oppure perché “è stato un incidente di percorso”, “lo volevo e ora non lo voglio più”, “Ma quando c**** si fanno grandi e se ne vanno af******* da questa casa?” e poi mancare di occuparsene, ed essere dei genitori fantasma non va bene. Se la ragione che vi spinge a farlo non ha nulla a che vedere con l’amore, lasciate perdere. Farete del bene a voi, ma soprattutto al potenziale nascituro risparmiandogli un sacco di sofferenze e traumi.
Per quanto concerne la seconda opzione (scrivere un libro/scrivere) …
Lasciate perdere pure questa strada. Non avete idea dei guai che combinate, travolgendo persone che non c’entrano niente coi vostri casini e che non vi hanno fatto nulla di male. Abbiate pietà, ve ne supplico.
Le parole possono salvare, ma il più delle volte uccidono.
¹ Nei criminali è annoverata anche la sottoscritta.
² È ironia, non ci avrete mica creduto?
³ “Che guaio grande!”. “Mamma mia, come stiamo messi male a guai!”
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Quando ero all’università condividevo la mia stanza con tre compagne di corso. La sera, dopo cena, quando non ci andava di guardare la tv, ci mettevamo a chiacchierare del più e del meno: di un aneddoto che ci era capitato durante la giornata, delle abitudini dei nostri genitori, ci cimentavamo in imitazioni e sfottò di persone di nostra conoscenza, ci scambiavamo barzellette, confidenze e, come sempre succede quando si è in gruppo, capitava che la conversazione virasse su storie di paura o film horror.
In una delle tante sere viene fuori che ci mettiamo a parlare di Psyco, film di Alfred Hitchcock del 1960 con Anthony Perkins nel ruolo di Norman Bates e Janet Leigh nella parte di Marion Crane. A raccontare la trama del film è Luciana.
Luciana era una ragazza molto originale – parlo al passato perché dall’università non ci siamo più riviste perché ognuna di noi ha imboccato strade diverse – e una accanita lettrice, ascoltava tanta musica, anche se generi non proprio comuni e lontano dalle melodie commerciali, e guardava tantissimi film. Non era espansiva con tutti (in realtà era timida ma non voleva darlo a vedere), si apriva quel tanto che bastava solo con chi era le era affine e mai più di tanto; era simpatica, intelligente, ironica, dal fisico grassottello che usava come corazza per difendersi dal mondo e nascondere le sue cicatrici e fragilità. Agli occhi delle altre si mostrava come una donna forte, prorompente, che niente e nessuno sarebbe riuscito a scalfire, sicura di sé e che sapeva il fatto suo. Osservava e immagazzinava. Taceva quando c’era da tacere, non parlava mai a vanvera e non criticava mai. Custodiva con gelosia e segretezza i suoi pensieri.
Per questo suo modo di essere, mi piacque da subito. Potevo passare intere giornate a studiarla a mia volta, in silenzio, proprio come faceva lei. C’erano giorni in cui mi dannavo per capire cosa le passasse per la testa, non si riusciva mai a comprendere fino in fondo di che umore fosse, era sfuggente, evanescente. Le altre ci avevano fatto l’abitudine, sapevano quando era il momento di lasciar perdere. A me, al contrario, la cosa faceva impazzire.
C’è da dire che al suo silenzio interiore si contrapponeva un casino al di fuori. Luciana era disordinata, lasciava tutto in giro: reggiseni, auricolari, carica batterie del telefono, scarpe, riviste, cd, matite, libri, evidenziatori, cibo avanzato, ferretti per capelli, spazzolino, arriccia capelli, boccette di profumo e altre chincaglierie…
Una sera l’assalì l’uzzolo di raccontarci questo film, che conoscevo di fama ma che non avevo mai visto sino ad allora. Ci confidò che era il film che le aveva messo più paura in assoluto e che era rimasta molto colpita dalla scena finale in cui Norman Bates, in una stanza adibita gli interrogatori del commissariato, con una coperta addosso svela il mistero delle uccisioni delle giovani ragazze al Motel Bates. È un ricordo che ho conservato nella testa anche dopo tanti anni perché, nel raccontarci la pellicola di Hitchcock, Luciana aveva trascinato una sedia al centro della stanza, ci si era seduta sopra, e aveva provato a riprodurre la mimica facciale di Anthony Perkins per trasmetterci quella sensazione di terrore che l’aveva sopraffatta la prima volta che aveva visto il film.
Lì per lì non capii subito cos’è che l’avesse spaventata così tanto, pur avendoci rivelato che a farlo era stata la coesione di due identità che abitano, e possono abitare, nella testa di un individuo (inutile che sto a narrarvi la trama di Psyco che, al contrario di me, conoscete tutti. È lo stesso Norman Bates ad uccidere le vittime, sotto le sembianze della madre morta la cui identità ha il sopravvento su quella del figlio). Allora (molto, molto superficialmente) dissi a Luciana che trovavo spaventosi molti altri film al posto di Psyco, dove non si vede altro che sangue, frammenti di carne e ossa e corpi umani sventrati dall’inizio alla fine. Rimasi sorpresa da ciò che mi disse. E fu come ricevere uno schiaffo in faccia.
“Carla tu non hai capito niente. I mostri, gli zombie, i fantasmi sono fantasie. I pazzi, le persone deviate, con disturbi e nevrosi sono reali. Esistono. A me fa paura pensare che queste persone le posso incontrare per strada, parlarci, e magari che possono diventare pure miei amici e che me li posso addirittura sposare. Posso guardare tutti i film con i mostri, gli alieni, le streghe e gli zombie dove si ammazzano l’uno con l’altro e dove si vede sangue dal principio alla fine, non mi fanno nulla. Non ho paura perché sono finti, mentre la gente affetta da doppia personalità esiste, e sono esseri davvero pericolosi. Poi tu devi guardare la faccia dell’attore che interpreta Norman Bates in quella scena finale…io mi sono cagata sotto”.
Va bene, mi son detta, è stata abbastanza esaustiva da farmi salire la curiosità di vedere questo film di Hitchcock divenuto tanto famoso nella storia del cinema. Così, alla prima occasione che mi capitò, mi misi a guardare Psyco.
La reazione che ho avuto la prima volta che l’ho visto è stata una non reazione, nel senso che mi aveva lasciata indifferente. Sì, qualche scena di suspense c’era eccome, le musiche erano molto efficaci nel creare le atmosfere cupe, la tensione si avverte, ma mi restava tutto tiepido. Per non parlare della scena di quando Norman Bates fa il suo ingresso in cantina con addosso il vestito della defunta mamma, la parrucca e il coltello in mano per uccidere Lila Crane. Ecco, mi sono messa con la dovuta attenzione a guardargli la faccia. E sono scoppiata a ridere come se stessi assistendo ad un film comico.
“Questa è scema” ho detto col pensiero rivolto a Luciana che ormai credevo del tutto andata e pensavo che non ci fossero soluzioni per recuperarla. “Ma come si fa a cagarsi addosso per scene come queste? Il tizio sembra un deficiente col vestitino di carnevale, la parrucca che pare un sorcio morto sulla testa e l’espressione di un pagliaccio che lo fa sembrare un emerito cretino”.
La scena finale (quella tanto temuta) confermò la mia visione “comica”, da macchietta, che avevo di questo film. Davanti ai miei occhi Perkins era una caricatura, un personaggio grottesco su cui aveva veicolato tutta l’interpretazione, rendendolo apposta eccessivo e fuorviante per rendere credibile il ruolo che era stato chiamato a svolgere. Non ci vedevo di nulla di spaventoso e, certo, non si poteva definire un film dell’orrore (almeno non come lo intendevo io che erano quelli dove si vedeva esclusivamente sangue e scene raccapriccianti).
Per apprezzare e assimilare un film, una canzone, un libro, un’opera d’arte, ci vuole del tempo. I film hai modo di vederli più volte perché vengono spesso riproposti in tv, oppure puoi guardarli su un dvd, al computer, sulle piattaforme digitali, sui programmi appositi, così come pure le canzoni che tornano con una certa frequenza nelle radio.
Ebbene di Psyco oggi ho il dvd. Lo riguardo e provo le stesse sensazioni che provò Luciana e che tentò di tradurci col suo racconto nella nostra stanza, una sera di tanti anni fa.
È agghiacciante, terrificante. Un vero capolavoro dell’arte cinematografica.
Le scene – tutte le scene –, persino quelle più banali come l’ufficio dell’agenzia immobiliare dove Marion lavora come segretaria hanno un che di inquietante. Sono suppellettili che accompagnano le intenzioni dei personaggi – non proprio pulite –, che vengono animate dalle loro psicosi e trovano voce anche soltanto con la propria presenza occupando lo spazio della scenografia. Pensiamo agli uccelli impagliati di Norman nel motel e decontestualizziamoli dalla pellicola: alla fine cosa sono? Dei meri oggetti che fungono da ornamento ad un ambiente. Cuciti nel tessuto del film acquisiscono tutt’altro aspetto e significato, diventano parte della storia, si fondono coi personaggi, sono strumenti che ci svelano la loro caratterizzazione.
Vorrei spendere altre due parole sul frame conclusivo, ma le espressioni di Norman Bates parlano da sole. Vi chiedo di non essere superficiali come è stata la scrivente in passato e di scrutare bene lo spezzone del film qui sotto riprodotto.
Ho parlato di espressioni, non espressione. Nel riquadro del film – è un video e i movimenti dei muscoli del volto rendono più facile il compito rispetto ad una fotografia dove bisogna aguzzare di più la vista – non c’è solo Norman Bates e sua madre, ci sono molti volti e molti stati d’animo. C’è un bambino, un adulto, una signora anziana, un innocente, una narratrice, un burlone, uno scanzonato, una spettatrice, un curiosone, un ozioso, un imputato. C’è dispiacere, preoccupazione, incredulità, sorpresa, orrore, scherzo, curiosità, indifferenza. C’è un pubblico. È un teatro in una stanza.
Anthony Perkins riesce a entrare e uscire nella parte di tutte queste persone con una facilità impressionante, nella “finzione” è bravissimo a non essere finto, mostra tante sfaccettature di sé e dell’individuo. Mette i brividi. Ho la pelle d’oca ogni volta che lo guardo.
“Brava Luciana!” sussurro a fior di labbra (per una strana coincidenza nella mia vita c’è sempre stato un Luciano o una Luciana, un Lucio o una Lucia che mi ha “illuminato” su tante cose).
Un autore che riesce a far provare le identiche sensazioni di terrore, angoscia e paura (PAURA) nei libri è Donato Carrisi. La sua tecnica di scrittura si è così tanto affinata che il lettore non si mette a immaginare la storia, ma la vive sulla pelle, sente la strizza scorrergli nelle vene. La vittima (quello o quella che dovrebbe fare da protagonista del romanzo) fa da comparsa, perché il soggetto che respira il panico, l’ansia, il buio, è colui che tiene in mano il libro. L’assassino, lo psicopatico, lo stalker non è nelle pagine del testo, ma si aggira per le scale, gli androni del palazzo del lettore e nelle stanze della sua casa (se apri il frigorifero o le ante dell’armadio lo trovi che ti fa cucù. Attenzione quando aprite soprattutto la porta del bagno, potreste trovarlo nella cabina della doccia o dietro le tende della finestra che vi aspetta).
Come mi salta in mente adesso Carrisi?
Me lo sono ritrovato nel letto, e non come amante – sia chiaro – ma perché ho la maledetta abitudine di leggere di notte perché è il momento della giornata che mi viene più facile immergermi nella lettura. Beh, gli effetti (soprattutto se si tratta di certe letture) non sono dei più rilassanti, lo ammetto, e non sono qui a persuadervi di leggere Carrisi a notte fonda
No, non questo… lo scrittore! Quello di Martina Franca, questo è di Cellino San Marco!
pure perché se vi venisse voglia di farlo non penso che sopravvivreste fino all’indomani mattina, specialmente se nel silenzio, e avvolti nel nero della notte dove al massimo a far un po’ di casino sono le cicale, passa una moto sgasando a tutta velocità col motore truccato e vi fa venire un infarto che arrivate già belli stecchiti sotto il fallo eretto del Camposanto… manco lo vedete l’ospedale, i medici e gli infermieri coi camici bianchi!
Manco la barella dell’ambulanza vedete, fidatevi! E non perché sto esagerando, ma perché è un autore che è davvero capace di farvi vivere nero su bianco la realtà. Pur trattandosi di thriller e di storie “inventate”, c’è molta verità (se è definito il maestro del thriller ci sarà pure una ragione più che plausibile).
Si fa fatica a distinguere il reale dal romanzato. Anche quando si conclude la lettura, parlo sia della chiusura di un capitolo (che poi non è mai una chiusura perché è una porta socchiusa dove si sbircia per buttare l’occhio oltre il consentito e scoprire che c’è un’altra porta da aprire) che della conclusione del libro, si rimane ancorati alla storia, e per affrancarsi c’è bisogno che trascorrano dei giorni prima che ci si possa sentire del tutto liberi dalle grinfie del male. Questa sua grande abilità di sedurre il lettore, di manipolarlo, incantarlo, è dovuta, presumibilmente, all’esperienza acquisita nel campo della criminologia e agli studi e alle pratiche correlati alla materia; in diverse interviste Carrisi ha anche dichiarato di essersi sottoposto alle tecniche di ipnosi che si sono rivelate utili per poter scrivere le sue storie (gli ultimi libri vedono scendere in pista l’addormentatore dei bambini Pietro Gerber, nell’ordine: La casa delle voci 2019, La casa senza ricordi 2021, La casa delle luci 2022, e La casa dei silenzi 2024) oltre ad una piccola curiosità: la sua prima fidanzata era spaventata da lui perché temeva fosse uno psicopatico (come darle torto? Anche qui, fossi stata in lei, avrei pensato la stessa cosa. Leggetelo per crederci).
Il confine tra realtà e fantasia non esiste. Mentre in altri testi è elargito ampio spazio all’immaginazione del lettore (e quindi egli si costruisce una realtà parallela a quella vissuta quotidianamente come una sorta di evasione), nei romanzi di Donato Carrisi c’è poco da immaginare. Per usare un linguaggio cinematografico, è molto hitchcockiano. Guardare i film di Hitchcock – a sua volta ispirato da un’altra autrice molto brava a costruire storie che ruotano attorno alla psicologia dei personaggi e che nella sua carriera è stata la sua musa ispiratrice – è come leggere i romanzi di Carrisi.
Il monito della mia compagna di università – che sapeva essere molto più arguta e perspicace della sottoscritta – era di esortarmi ed essere più pragmatica e meno “favoleggiante”, di affinare la mia capacità di osservazione e di non farmi trascinare troppo dalla superficialità e impulsività delle situazioni.
Non era un caso che fosse una persona fuori dal comune con la quale tessevo codici di comunicazione noti solo a noi due, che ci permettevano di scoprirci e riconoscerci pur restando in silenzio.
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
«Hai mai fatto caso che le opere d’arte non le guarda più nessuno, ma la gente ne parla soltanto?»
«È un bene che ne parlino. D’altronde l’arte serve a questo, a far parlare».
Carlo Paris (Giancarlo Giannini) a Sofia Moretti (Elena Lietti) in Gioco pericoloso, pellicola del 2025 diretta da Lucio Pellegrini.
«Che stanno facendo adesso?»
«Stanno sistemando i fili della corrente elettrica»
«Ma era necessaria questa cosa?»
«Certo che era necessario! L’edificio stava cadendo a pezzi, andava sistemato».
Conversazione tra tre uomini in strada mentre osservano, a naso in su, un palazzo del centro in una mattina di inizio settimana. A parlare sono solo in due, il terzo fa da spettatore accanto ai due compari.
(In libreria).
«Purtroppo quella è l’unica copia che ho al momento»
«Non vorrei che finisse col rovinarsi, ci tengo ai libri e vorrei che anche loro li trattassero come li tratto io»
«L’unica cosa che posso fare è ordinarle un’altra copia, se ha fretta di leggerlo prende intanto questa e quando arriva viene a cambiarla»
«No, prendo questa. Magari ci poggio un libro sopra e si appiana… oltre a trasmettere il valore della lettura mi piacerebbe pure che imparassero a rispettarli i libri… capirai! Io sono una divoratrice di libri, in genere li leggo in 24 ore… Lascia questo ce l’hai (dice la acquirente rivolta alla bambina che è con lei, forse la figlia; n.d.r.). Il libro più bello che ho letto in assoluto è Tutto il blu del cielo di Da Costa»
«Ah, ho capito. La scrittrice è quella francese?»
«Lo ha letto anche lei?»
«No quello ancora no, ma ho capito chi è l’autrice»
«Ho letto pure I quaderni botanici di Madame Lucie sempre della Da Costa, bello anche quello ma non quanto Tutto il blu del cielo che mi ha aperto un mondo»
«Che libro è?»
«Parla di un ragazzo che ha l’Alzheimer e decide di intraprendere un viaggio prima che la memoria gli scompaia del tutto e in questo percorso scoprirà tante cose che… vabbé, ora non voglio spoilerare ma è da leggere assolutamente! Sono seicento pagine ma si fanno leggere, anche se la scrittura in alcuni passaggi è molto densa e ha bisogno di più tempo per essere assimilata; io che di solito, come dicevo prima, leggo un libro in un giorno, con questo ho impiegato uno due giorni in più, ma di sicuro posso dire che è il libro più bello che ho letto in vita mia»
«Come ha detto che si chiama? Tutto il blu del cielo?»
«Tutto il blu del cielo, sì. Ma… magnifico, veramente»
«Grazie per il suggerimento»
«Prego, si figuri. A volte è bello confrontarsi».
(Audio estratto da una chat whatsapp. Una bambina gioca col cellulare della mamma).
«Nonna sì… Palo…»
«Lascialo stare a Paolo, canta la canzone del pesciolino»
(Si ode in sottofondo una cantilena incomprensibile).
«Che devi andare a Sanremo, tu?»
«Una scimmetta sattava sul letto/ una cade giù e si rumpe il cervelletto/ la mamma il dottore/... e un dett…»
«Però è molto sensuale»
«Essì però… non è tutta ‘sta cosa»
«Dai che è brava»
«Bella è bella, ma non sa recitare»
«A me piace, certo è diversa da quando stava a Amici»
«Come si chiama?»
«Di Patrizi. Elodie Di Patrizi. Il padre era un ex artista di strada, la madre una ex modella di Guadalupa, perciò lei ha questi tratti del viso così particolari. La madre non è italiana»
(Al cinema, una coppia commenta la performance di Elodie mentre scorre informazioni sull’artista sullo schermo dei rispettivi cellulari).
«Non ce la fanno più, non ce la fanno proprio più… mo’ devono vedere come devono fare»
«… si sveglia pure presto perché deve andare a lavorare»
«Ieri notte la bambina li ha fatti stare svegli tutto il tempo»
«Quando sono piccoli così è»
(Per strada, conversazione tra coppie mentre una di esse se ne sta affacciata alla finestra del piano rialzato del palazzo. Accanto c’è un’altra finestra coi panni stesi ad asciugare).
(Al supermercato. Due ragazze stanno tirando fuori la merce dagli scatoloni per sistemarla sugli scaffali. Il cassiere, forse il titolare, tiene un occhio al registratore di cassa e un occhio alle dipendenti).
«Baby so che mi guardi/anche se la notte è buia/non sei come gli altri/dimmi come sei tu/Noi sotto una luna piena/ lingue intrecciate, bottega/ sai di tre stelle, Bottura/pelle d’oca sulla schiena/e io sento Einaudi quando ti muovi sopra me/dipingi con le mani, io rinasco come Venere…»
«Bella ‘sta canzone… come si chiama lei?»
«Rose Villain»
«Rose Villan?»
«Rose Villain!»
(Risate, ride anche il cassiere).
«Lei tiene tinti i capelli di blu, tu quando ti tingi i capelli di fucsia?»
«Ma stai zitto che mia nipote mi guarda stamattina e mi fa “zia, ma quando ti vai a tingere i capelli?”»
«Non me ne frega un cazzo, hai capito? Non mi mettere in mezzo ai tuoi casini! Tu vuoi solo pararti il culo Giovi, lo dici solo per pararti il culo!»
(Breve pausa).
«Ma io te l’ho detto, te l’ho detto! Ascolta… ascoltami Giovi… lo dici per pararti il culo! Tu ti vuoi parare il culo Giovi! Sei un gran paraculo! Sei bravo solo a pararti il CULO!»
(Lo sciorinamento di improperi e nefandezze dalla bocca di una “signora” continua mentre cammina per strada urlando al cellulare).
(A scuola di ballo).
«Ora i passi del samba li sapete tutti, ne manca solo uno e poi abbiamo concluso il programma»
«Qual è? Come si chiama l’ultimo passo? Diccelo ché siamo curiose»
«L’ultimo passo è il ronde, ossia il giro che è questo».
(Segue dimostrazione).
«Dovete immaginare che ci sia dietro l’uomo che vi spinge mentre voi ruotate su voi stesse, dovete solo immaginare però, perché l’uomo non esiste».
«Meglio così, sint a me¹. Quelli lasciamoli stare».
«A immaginazione stiamo messe bene, pure a fantasia non preoccuparti».
«È il resto che lascia a desiderare».
«Vi dovete aiutare con le braccia a riempire la scena, almeno questo è quello che facevo io durante le gare di ballo. Casomai poi facciamo una prova, vi divido in gruppi: una parte di voi fa la femmina e l’altra fa il maschio»
«Io posso fare il travestito?»
(Alla radio, uno speaker rivolto all’altra speaker).
«Senti questa: “Ragazza stufa scappa di casa e i genitori muoiono di freddo”».
Ridono prima di lanciare la pubblicità.
«Ma domani va in piscina?»
«Sì, domani assolutamente sì. La tosse le è passata del tutto, anche se per andare via ce ne ha messo di tempo. Si è fatta due settimane di antibiotico ma niente, questa tosse proprio non passava…»
«Mamma mia!»
«… poi lo ha cambiato, si è fatta un altro ciclo di antibiotico e ora sta bene»
«Un incubo»
«Nooo, sono impazzita… c’era da impazzire guarda…»
(Per strada, conversazione tra donne).
«Voglio raccontarvi una barzelletta»
«No, no... è orribile»
«Sì è vero è orribile, ma mi è venuta in mente pensando al tema del libro di questo incontro. Allora c’è un uomo che deve sposarsi, e tra tre donne deve scegliere quale di queste tre prendere per moglie. Per uscire dalla sua indecisione, affida a ciascuna di loro cinquemila euro prelevate dal suo conto bancario per vedere come si servono di questi soldi. Quando domanda alla prima cosa ha fatto col denaro che le ha dato, questa risponde “Amore ho prenotato una bellissima vacanza ai Caraibi, immagina: io e te circondati da spiagge tropicali con camerieri che ci servono cocktail, aperitivi e champagne sotto l’ombrellone, un albergo di lusso, sole, mare, lontano da tutti in pieno relax…” Il tizio ci pensa e fa “mhm, non male”. Poi chiede alla seconda “Amore, cosa hai fatto coi cinquemila euro che ti ho dato?” e questa risponde “Amore guarda, mi sono sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica additiva, adesso ho un bel seno, delle belle labbra, un bel fondoschiena, ho modellato il mio fisico frequentando tutti i giorni la palestra, faccio massaggi in un centro estetico, e tutto questo solo per te amore mio, solo per noi due”. Poi arriva il turno della terza, e porge la stessa domanda che ha fatto alle altre. “Guarda caro, i soldi che mi hai dato li ho investiti tutti in case, proprietà, terreni, ho aperto un altro conto in banca, ho avviato un’attività commerciale, sto procedendo con altri finanziamenti per mettere su un’impresa in modo che una volta sposati non ci possa mancar nulla, in poco tempo ho raddoppiato la cifra che mi hai dato…” risponde la donna. Passano le due settimane che l’uomo si era concesso per fare la sua scelta e nessuna delle tre donne è ancora a conoscenza del responso; allorché queste lo chiamano, lo mettono spalle al muro e gli chiedono cosa ha deciso. Lui le guarda tutti e tre e, sospirando, risponde “Eh… ci ho pensato a lungo, e ho deciso che alla fine sposerò quella che ha speso i soldi per rifarsi le tette e il culo”».
(Intermezzo di una discussione all’interno di un incontro letterario organizzato dall’Associazione culturale Foggia Legge per dialogare del libro di Patrizia De Luca, Tettagna Edizioni e/o, vincitore del sondaggio “Opera Prima”).
(Roma, tra Piazza Venezia e Largo Argentina)
Un clochard cammina sui marciapiedi della Capitale e ogni tanto si ferma a urlare alle buste di plastica che svolazzano per strada tra cartacce, detriti di polvere e smog. Quando le buste si risollevano da terra e riprendono a volare in aria come palloncini spinti dal vento, l’uomo ricomincia a camminare fino a quando non ne incontra un’altra. Stessa storia, stesso iter: la busta si ferma a terra davanti ai suoi piedi e sotto ai suoi occhi. Inizia a inveire contro essa.
La gente che percorre le vie, staziona i marciapiedi e attraversa le carreggiate di quella porzione di centro della città sospende per un attimo le proprie incombenze, e si mette ad assistere alla scena che offre il clochard. Negli sguardi delle persone si coglie spavento, sorpresa, ansia, preoccupazione, pericolo, ma in tutti questi stati d’animo ce n’è uno che fa da comune denominatore: la curiosità.
Dopo aver scoperto chi e cosa ha scatenato gli strilli che hanno squarciato un grigio mattino di novembre per le strade del centro della Capitale, il pubblico spettatore si è lasciato andare a risate divertite come se stesse assistendo ad un cabaret. E più il clochard esprimeva il suo disagio con i gesti, il tono della voce, epiteti reiterati ad ogni busta che ha incrociato il suo cammino, più lo scroscio delle risate è aumentato di tono e di numero tra i passanti.
“È solo un pazzo” è ciò che trapela dagli occhi e dalle bocche di quegli esseri umani così simili (eppure così diversi) al clochard.
Mi fermo anch’io ad osservarlo mentre ascolto quello che dicono e indicano gli altri intorno a me con un movimento della testa, con il dito puntato, facendo segno al compagno o alla compagna accanto con gli occhi o con un alzata di mento, e col sorriso che deforma le loro facce. E mi domando:
“Ma siamo sicuri che è lui ad essere il pazzo e noi quelli normali?”
¹ Trad.: “Senti a me, ascoltami”.
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Non avere un amore. La scelta tra definirla una privazione o una liberazione dipende dall’umore e dal momento.
Dio ha creato l’uomo con il pene e il cervello, ma si è dimenticato di dargli abbastanza sangue perché possano funzionare insieme.
Sembra che molti uomini perdano del tutto il raziocinio quando quell’appendice, tra l’altro piuttosto buffa, decide di fare l’osso duro.
Nessuno può essere giudicato senza essere prima ascoltato.
L’amore ci dà molto nella vita, forse perfino tutto l’essenziale, ma di rado la sicurezza.
Parlare, ho parlato più che a sufficienza, ma non c’era nessuno che mi ascoltasse.
Il peggiore ostacolo all’amore, come all’integrazione, è un cuore che comincia ad arrendersi.
Le massime che precedono sono tratte dal libro di Björn Larsson, Filosofia minima del pendolare (pagine 225, Iperborea Editore 2025).
Come avrete notato, di un libro che mi colpisce sono solita stilare una recensione, nel caso di Larsson diventava complesso.
Prima di tutto perché non è un testo di narrativa ma di “filosofia” – più che filosofia sono appunti raccolti nel suo pendolare dalla Svezia alla Danimarca e in altre nazioni per motivi di lavoro e altro che inducono a infinite riflessioni – e poi perché gli argomenti da affrontare sono tanti (questi sono solo una piccolissima parte) e sarei stata costretta a frammentare l’articolo in due o più parti.
Cominciamo col dire che una delle cose che mi è piaciuta di questo libro è stata la trascrizione dei dialoghi dei passeggeri su un traghetto, tra un treno e l’altro oppure tra un bus e una metro. Voi non fate mai caso a quante storie si celano dietro a un dialogo? Leggendole è salito anche a me il desiderio di annotare su un taccuino i discorsi e le mezze frasi che due persone si scambiano in un negozio, sedute su un vagone di un treno, oppure di un individuo che attraversa la strada ed è impegnato in una conversazione al telefono. Confesso che è un gioco che mi ha sempre divertita perché mi dà modo di immaginare che dietro quelle parole, dietro le espressioni di un volto (o le imprecazioni), nelle abitudini di scegliere quale abito indossare quel giorno, ci sia una storia personale e un’altra che si può ancora costruire e inventare. Rubare persone alla vita reale per trasformarle in personaggi di un romanzo o di un racconto. È quanto mi propongo di fare per un post/articolo futuro.
È un passaggio presente anche nel libro, dove l’autore in parte spiega – e deduce – un’intuizione scaturente dal dialogo di due adolescenti, e dall’altra parte la scena è soltanto abbozzata lasciando il lettore alle sue riflessioni (o fantasie).
Passiamo alla fase successiva. Le massime contengono argomenti che, più di una volta, mi sono trovata ad affrontare in questa sede. Uno di questi è l’ascolto.
Non mi ricordo dove ho letto che la mancanza di comunicazione è la causa del principale fallimento di una relazione d’amore. Sono inciampata recentemente in questo aforisma ma, con tutto quello che leggo durante le ore del giorno, faccio fatica in certi momenti a ricordare ciò che mi entra nella testa attraverso gli occhi e le orecchie. Il triste panorama su cui ci affacciamo appena svegli, però, non fa che confermare quanto sia vero il precetto. Adesso, per esempio, non so perché mi risuonano in testa le note di Words una lirica di Madonna facente parte dell’album Erotica del 1992 (ricordo che ai tempi avevo la musicassetta e che la canzone era la seconda del lato B) il cui ritornello faceva così:
Words
they cut like a knife
cut into my life
I don’t want to hear your words
they always attack
please take them all back
if they’re yours I don’t want anymore
e, sempre a proposito di questa canzone, mi viene in mente anche il video in cui lei (Madonna) viene vessata dal suo amante/compagno/spasimante attraverso le parole di quest’ultimo, che esercita su di lei delle pressioni oltre che fisiche anche psicologiche, volte a renderla un pupazzo, una schiava, un oggetto. È interessante notare come un video dei primi anni ’90 anticipasse quelli che nel secolo attuale sono ormai i temi caldi – più che caldi, brucianti – del giorno.
Parole. Se ne dicono tante. Larsson si sofferma anche su quest’aspetto. Fa un’analisi matematica sottraendo, moltiplicando, aggiungendo; in certi passaggi del libro è come avere in mano un tomo di matematica o di fisica quantistica che esamina attentamente particolari a cui un individuo, nel corso della vita di tutti i giorni, non fa caso. Avete mai pensato quante parole si dicono al giorno? Quanto fiato, quanta aria viene buttata fuori dalla bocca stante l’enorme numero di esseri umani presenti sulla Terra? Che fine fanno queste parole? Dove cadono queste parole? Quante di esse vengono recepite, comprese, assimilate?
Stamattina facevo un’altra riflessione.
Tra le VIP impegnate nelle battaglie contro il femminicidio c’è chi decanta la solidarietà femminile promuovendosene sostenitrice, nonché fervente credente (perdonate il gioco di parole). Alcune di loro (non tutte), per avvalorare la loro tesi, e quindi convincere quante non ci credono, cercano di ribaltare la questione – che è sotto gli occhi di tutti – facendo ricadere la colpa agli uomini attraverso questo assunto.
Le donne devono sempre lottare per dimostrare di non essere inferiori al maschio, esse hanno uguali diritti che, come tali, devono essere riconosciuti (e fin qua nulla da obiettare). Se la solidarietà femminile non viene vista di buon occhio – anzi, non viene proprio vista perché non esiste – è perché le donne, singolarmente, sono troppo concentrate a dimostrare al “nemico” che sono capaci (tanto quanto lui e anche di più) in quello che fanno e questo, a malincuore, va a discapito delle altre compagne di battaglia, generando un falso antagonismo tra le stesse (falso, perché tutte combattono la stessa guerra).
Mi rendo conto che il ragionamento è contorto, e lo è perché di fatto è così.
Io voglio bene a tutti. Maschi, femmine, omosessuali, trans gender, asessuali, asessuati, angeli, diavoli, perché ognuno deve fare come si sente di fare e deve essere quel che realmente è (non tollero in nessuna maniera bugie, falsità, apparenze e soprattutto non mi piace porre limiti alla libertà di un individuo e vedo nero con quanti lo fanno) a patto che rispetti l’altro e che non gli arrechi fastidio, danno o pericolo. Mettiamo in chiaro una cosa però: la solidarietà femminile non esiste e mai esisterà. Come lo so? È scienza¹.
Quindi smettete di credere a quante cercano di convincervi del contrario (e soprattutto non andate appresso alle fandonie che scrivono sui social ormai sorgente a disposizione di tutti, in special modo di giornalisti, dove attingere notizie o scoop).
Non ci vuole comunque la scienza dirvelo, basta osservare e accorgersi di quel che accade sotto i vostri occhi e il vostro naso. L’ultimo episodio è quello tra un’attrice e una scrittrice che si sono beccate tra loro in nome di una presunta gratitudine e di un altrettanto presunto riconoscimento. Un chiaro esempio della famigerata solidarietà femminile.
Potrei riportarvi altre situazioni ma, non essendo questo un luogo per il gossip, per chi fosse interessato a tali argomenti è pregato di visitare i siti preposti a tali scopi.
Il testo di Björn Larsson è un binocolo sul mondo perché esplora dettagli che, all’occhio comune, passano in secondo piano. Tra i tanti temi è menzionato anche il Covid-19, e le tracce che questo virus ha lasciato in ognuno di noi dal preciso istante in cui ne siamo rimasti contagiati (questo il libro non lo dice, ma tutte le premesse portano alla triste conclusione).
Possiamo dire di aver superato definitivamente la fase Covid e di essercelo lasciato alle spalle? Ricordate gli sciocchi slogan “Andrà tutto bene”, “Torneremo più uniti di prima” e il motto dell’allora premier Giuseppe Conte “Siamo distanti oggi, per abbracciarci con più calore domani”? Quanti di questi pronostici sono andati a buon fine?
Le distanze sono raddoppiate, i muri (che speravamo di aver abbattuto e quelli ancora presenti che fingiamo di voler abbattere) sono diventati più alti e massicci, la comunicazione è andata a farsi benedire e nel frattempo sono scoppiate pure due guerre! In quattro e quattr’otto ci siamo scordati di tutte le belle speranze, delle canzoni cantate affacciate a un balcone o a una finestra (col vicino di sotto, di sopra o a fianco che sbraitava perché non ne poteva più) per urlare gioia, speranza e solidarietà e, pertanto, che soffrivamo per le privazioni e l’isolamento imposto… e tutto questo per cosa? Per perseverare a vivere da isolati, per continuare a lavorare in smart working, per stare lontano dalla gente, e per sentirla o vederla – invero insultarla è il termine corretto – tramite uno schermo.
Sfatiamo il mito che il peggio è ormai passato. Il virus esiste ancora. Ed è ancora più virulento e spaventoso (è il patogeno che temo più di qualsiasi altro morbo, che mi ha fatto sempre paura, sempre me ne farà, ed è fin troppo sottovalutato).
E dirò di più. Il virus c’era già da prima che si propagasse in maniera così dilagante, il 2020 è stato il punto di rottura e di non ritorno. Tutti lo conosciamo con la nomenclatura di Covid, in realtà il suo vero nome è Ignoranza.
Il lockdown era un ottimo pretesto per curarci da questa malattia dato che avevamo tantissimo tempo a disposizione per dedicarci alla cura dello spirito. In tanti, quasi tutti in realtà, hanno preferito non solo rifiutare l’antidoto, ma addirittura sguazzarci nella malattia inzaccherando² il proprio vicino.
Le conseguenze di quella scelta le stiamo pagando oggi ancor più del passato. Chi, all’epoca, aveva inteso il lockdown come una prigionia e non come un contraccettivo al virus ha contribuito ad appesantire e ingigantire quelle catene che lo derubavano della libertà e che, ancora adesso, lo tengono in pugno rendendolo uno schiavo della società che ha creato, fecondandola col seme della sua stupidità.
Ognuno è responsabile delle proprie azioni. Frase già detta, letta e ripetuta stra-milioni di volte… ma siete sicuri di capire bene il significato delle parole?
Io mi sono fatta persuasa – prendendo in prestito uno dei sicilianismi di Montalbano, “figlio” di un grande autore qual è Andrea Camilleri – che, essendo ormai il mondo gremito di tuttologi, la gente le usa senza conoscerne il significato; volendo spiegare meglio il concetto con un esempio, è come se il medico che deve misurarti la febbre invece di utilizzare il termometro utilizza l’otoscopio. Ora, di medici sprovvisti di abilitazione ad esercitare e senza titolo di studio ce ne sono, ma non penso che il loro numero sia pari o superiore agli esperti in Tuttologia.
Mhmm (mumble muble).
Sull’argomento amore la faccenda si complica. Questo è un campo su cui possiamo stare ore a discuterne, e quando dico “ore” è da prenderlo come un eufemismo perché qui pure un’infinità di vite sono poche per comprendere questo strano sortilegio che ha il potere, la capacità, la forza, la magia, di trasformare le persone (sia nel bene che nel male). Dapprincipio avevo deciso di saltare questa materia, ne darò solo qualche cenno.
Partiamo col dire che non ho mai capito chi, tra uomo e donna, diventa più rimbambito (un’altra terminologia sarebbe più azzeccata, ma volgarotta) quando è preso dai fumi di questa droga. Una cosa è sicura: scemi si arriva a essere scemi (ma proprio scemi, eh?), qualcuno può credere non in egual misura io invece affermo che la misura è la stessa, sono le modalità ad essere diverse. La donna ha un approccio più emotivo, più romantico, più sognatore – proprio stamattina³ leggevo un articolo su La Stampa che il genere dei romanzi più letti sono, ahimè₄, i romance che si mescolano al fantasy e alle graphic novel –, l’uomo ha uno slancio più istintivo, più passionale, più viscerale, più di pancia (sotto cintura, per intenderci). Le massime di Björn Larsson non lasciano dubbi in merito. È un fatto costitutivo, insito nella natura di una e dell’altro. La frase – Larsson specifica nel testo che è di una femminista americana – Dio ha creato l’uomo con il pene e il cervello, ma si è dimenticato di dargli abbastanza sangue perché possano funzionare insieme è la prova provata di quel che ho appena enunciato (ora però chiedo ai maschietti di non avercela con me e soprattutto di non fucilarmi). Per principio di completezza e trasparenza devo aggiungere che Larsson è d’accordo con questa massima, e infatti prosegue dichiarando: «C’è del vero in questo. Sembra che molti uomini perdano del tutto il raziocinio quando quell’appendice, tra l’altro piuttosto buffa, decide di fare l’osso duro₅».
In sintesi: le donne amano col cuore, gli uomini amano con l’appendice. Non è carina come osservazione, ma è così (L’amore è una questione di organi, cit. Charlie. Vi piace? L’ho partorita adesso).
Il bello (o il brutto) – la vita, e con essa le sue pertinenze, è sempre una questione di prospettive e di soggettività – arriva quando tocca capire dove termina il confine con il sesso e comincia quello dell’amore.
Non ho una grande opinione degli uomini. Sarà sfiga, ma finora tutti quelli che ho conosciuto erano uno la fotocopia dell’altro. Non hanno una identità, una originalità, una verve, qualcosa che mi ha affascinata e che mi ha spinto a nutrire un sentimento di attaccamento, di valore, di profondo. Sono d’accordo con Mina quando canta “semplici e un po’ banali, io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini e l’amore, come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, dai che non siamo poi cattivi…”₆
Prevedibili. Sì, è la definizione esatta. Il loro denominatore comune.
Per par condicio devo ammettere che anche delle donne (almeno non di tutte) non ho una grande stima. Quando vogliono – ed è una scelta consapevole che fanno perché sanno di non essere così – sanno essere davvero stupide e scadere anche loro in una superficialità inaudita che agli occhi di chi le guarda li obbliga a ritenerle tonte e pazze.
La differenza tra maschi e femmine sta tutta qui. Le donne sono consapevoli, e quindi se decidono di adottare un certo comportamento o un atteggiamento è per una loro scelta. Gli uomini non sono consapevoli di ciò che fanno, e lo sono di natura. Azzardo: è l’uomo ad essere istintivo e la donna razionale, non il contrario.
Resta il fatto che determinate scelte da parte del mio sesso (per quanto le apprezzi) non le condivido, specie se le fanno passare come strumenti per indurre a sconfiggere concezioni di pensiero stereotipate (producendo l’effetto contrario, non la demolizione della concezione anacronistica del pensiero). Per come la penso io, in un uomo devo stimolare il cervello non il p****lo.
Nonostante ci sia ancora tanto da dissertare perché, come dicevo, il libro è ricco di spunti di riflessione, volgo alla conclusione regalandovi un paio di pagine che appartengono a Maktub, testo di Paulo Coelho (La Nave di Teseo Editore, 2023), per invitarvi ad aguzzare la vista sulla scena che si schiuderà ai vostri occhi e a prestare orecchio su tutto quanto vien detto dalle persone coinvolte in questa storia.
¹ La conferma al dubbio della sottoscritta è arrivata dalla risposta di una psichiatra e psicoterapeuta la quale ha dichiarato che non è ipotizzabile l’esistenza della solidarietà tra donne, in quanto biologicamente connaturato al sesso femminile l’istinto di protezione della specie che si estende a tutti gli altri campi.
² Il lemma qui sta per contagiare.
³ Nel momento in cui questo post viene redatto è il 5 marzo 2025.
₄ Ma perché fate queste cose?
₅Cit. nel testo.
₆Acqua e sale, brano dell’album Mina Celentano del 1998.
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Ieri notte ho sognato il Dottor Angela.
Visitavamo assieme luoghi, dissertavamo di vari argomenti, lui mi presentava personaggi, conoscenti… insomma eravamo come una coppia di vecchi amici che hanno piacere di rivedersi dopo tanto tempo. Mi sono svegliata con una sensazione bellissima (‘na volta tanto, vuoi mettere un giorno con Alberto Angela?).
Beh, retorico dire che il Dottore è un uomo affascinante. In tutti i sensi. E non c’è bisogno di sognarlo per poter affermarlo con sicurezza, semmai uno lo sogna appunto perché è un bell’uomo. Peccato che come tutte le belle persone sia già occupato (ok, basta così Charlie. Non aggiungere altro prima che tu faccia danni, l’ammirazione che serbi per il Dottor Angela è abbastanza chiara; se continui ad andare avanti va a finire che poi ti vergogni di quello che scrivi).
Alberto Angela, come il suo grande papà Piero, è uno dei pochissimi autori che merita, come infatti ha meritato e come prima di lui il genitore, più di un Premio – nel corso della sua carriera ha ottenuto il Premio Cimitile, il Premio Flaiano, il Premio Fregene, il Premiolino, il Guidarello d’oro, il Premio Portico d’oro Jacques Le Goff, il Premio America e tanti altri, oltre ad una serie di onorificenze – per la sua cospicua attività divulgativa in ambito scientifico, storico, geografico, antropologico, paleontologico, che ha permesso di approcciare i giovani (e non solo) alla cultura e a trasmettere loro la sete di conoscenza.
La riflessione sgorga da più basi di pensiero.
In questi giorni stanno circolando le notizie riguardo ai primi nomi che presumibilmente rientreranno nella cinquina del Premio Strega. Ovviamente il citato premio non è l’unico in ambito letterario, c’è il Premio Campiello, il Premio Bancarella, il Premio Pulitzer, il Premio Nobel, il Premio Goncourt… ma concentriamo la nostra attenzione sul Premio Strega, che è quello più discusso e non diverso da tanti altri.
A cosa servono questi premi?
Quando andavo a scuola – anche oggi vado a scuola ma in maniera diversa, non è proprio il luogo dove sedevo dietro ad un banco ma sempre una scuola è, sia che sia autodidatta o che riguardi corsi di specializzazioni o altro – la maestra, il professore, l’insegnante, assegnavano un premio al più bravo della classe. Vero è che gran parte di questi premi era in sostanza un premio alla bravura dello scolaro che si era distinto dagli altri per la sua intelligenza, la sua abilità e non da ultimo anche per la sua disciplina. Il premio, dunque, aveva una valenza soggettiva (diretto ad enfiare l’orgoglio dell’alunno) e una valenza oggettiva (fungere da esempio agli altri). Aveva una sua utilità.
Ricordo che quasi tutti i giorni si scatenava una gara volta a mettere in luce chi eccelleva più degli altri; il tutto avveniva in modo genuino, non era uno scavalcare i compagni in maniera irriguardosa, piuttosto una sana competizione che ci rendeva tutti delle persone migliori perché ci impegnava a cacciar fuori il nostro talento e a far funzionare le nostre capacità.
I premi letterari a cosa servono? È da quando ho scoperto il piacere della lettura che me lo chiedo. Non hanno nessuno scopo se non quello di glorificare ed enfatizzare la vanità degli scrittori. È un premio fine a sé stesso, che non apporta nessuna utilità ai lettori e che ha significato solo nel circolo dei letterati (autori, giornalisti, saggisti, critici).
Un premio ha valore se è di aiuto, di esempio ad una persona (società), che la supporti nella sua attività di crescita. Proprio come succedeva quando eravamo in classe alle elementari. Il fine non deve essere solo soggettivo, ma deve abbracciare la platea dei partecipanti: se la premiazione comporta solo un riconoscimento personale, escludendo la cerchia delle persone, che senso ha? Qual è il valore del premio?
Il confronto che mi viene in mente è simile a quello di un individuo che ha la possibilità economica di acquistare un abito di Prada o di Miu Miu rispetto ad un altro che non dispone di tanto denaro e ripiega su merce da bancarella (tanto per restare in tema). Il paragone rende l’idea se immaginiamo gli scrittori come i più abbienti e i lettori come i meno abbienti. I più abbienti fanno a gara a chi veste meglio e a chi si fa notare di più (e possono farlo solo loro che appartengono ad un certo “ceto”), mentre i meno abbienti non possono far altro che stare a guardare o tutt’al più ammirarli (gli esclusi dal “ceto”).
Un Direttore di giornale con cui ho piacevolmente collaborato in passato scansava ogni argomento che aveva a che fare con i Premi letterari. Diceva sempre che ci credeva poco. Rispecchiava quella che col tempo è diventata mia opinione consolidata, e cioè che questi premi siano troppo sopravvalutati.
Un post di qualche mese fa (ora si chiamano post non più articoli, che dobbiamo fa’? Ci dobbiamo adeguare alle nuove tecnologie e, di conseguenza, ai nuovi slang) ha rafforzato il mio convincimento. Rendeva noto che un autore – deprezzato dalla critica intellettualosa che conta – in tutta la sua carriera aveva vinto un solo premio: il Premio Bancarella. Il post metteva al corrente del momento in cui si svolse la premiazione, dei minuti di imbarazzo che pervasero l’atmosfera e dello stato d’animo del premiato. Perché imbarazzo? Perché l’autore in questione, tra i presenti in sala, non era ritenuto degno del Premio (e gli addetti alla manifestazione non mancarono di farglielo notare con tutti i mezzi a disposizione).
L’episodio appena descritto fu narrato dallo stesso scrittore in uno dei suoi libri. Dobbiamo solo ringraziare la buona sorte della appagante – e meritata – riuscita della vicenda, e non il giudizio e la considerazione dei cosiddetti “critici”, perché fu la voce del popolo a parlare e a decretare che i suoi scritti avevano sortito gli effetti che ci si aspetta da chi scrive libri, ossia diffondere l’amore per la cultura e la conoscenza, stimolare la curiosità verso tutto ciò che circonda l’essere umano (oltre ad educare ai buoni sentimenti affinando la sensibilità di chi legge per far sì che si sviluppi empatia col prossimo), far conoscere ed apprezzare il piacere della lettura, accrescere ed eccitare l’immaginazione, e stuzzicare il gusto di andare sempre a caccia di nuovi viaggi, nuove avventure e nuove scoperte.
In fondo è questo lo scopo dei libri. Non siete d’accordo?
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
“Ma oggi non è il 14 febbraio!”
E invece è proprio così, oggi è il 14 febbraio (per la gioia di tutti i romantici) solo che, come fa notare lui, non c’è bisogno di aspettare un giorno dell’anno per dichiarare (o mostrare) l’amore a una persona.
Che poi questa persona sia la metà del proprio cuore, oppure un amico o amica, un cane, un gatto, un fratello, una nonna o un cugino alla lontana poco importa; voler bene a una persona non lo si deve intendere esclusivamente come il sentimento che unisce due innamorati, occorre tenere in considerazione il significato lasco del termine. Perché sempre di amore si tratta. È la misura del sentimento che è diversa. Un esempio ci aiuterà meglio a capire il concetto.
Esaminiamo la frase Ti voglio bene. È una frase che viene usata prevalentemente tra amici o tra nonni e nipoti o tra padre-madre-figli, raramente tra amanti che si dicono e si sussurrano Ti amo.
Nella sostanza non cambia nulla, il sentimento è quello.
Pronunciare “ti voglio bene” significa “voglio vederti in salute, voglio che tu sia allegro e spensierato, non desidero altro che la tua serenità". Nel momento in cui manifesto questo impulso emotivo all’altra persona le sto dicendo che mi sto preoccupando per lei, che non mi dà noia aiutarla o farle un favore, che non fatico ad assisterla o a rivolgerle una parola di conforto, che me ne prendo cura perché mi sta a cuore il suo benessere fisico e spirituale.
Tutte queste azioni non vengono naturali se non sono sorrette dal sentimento che sta alla base di tutte le relazioni, che è il sentimento di amore.
Un amico lo aiuto, lo ascolto, gli sollevo il morale quando è giù di corda; ci esco, mangio assieme a lui, dormo insieme a lui, viaggio con lui, sono felice quando stiamo assieme o lo rivedo dopo tanto tempo, mi piace la sua compagnia. Faccio notare che una situazione simile è riscontrabile anche in ambito familiare; a tal proposito, mentre scrivo mi sovviene in mente la mia piccola nipotina la quale, appena il fratello varca la soglia della porta di casa al rientro dalla scuola, non gli dà neanche il tempo di spogliarsi e mettersi comodo che se lo abbraccia e non lo molla più, correndogli appresso nel corridoio, nelle stanze e persino nel bagno (è o non è amore questo?).
Stessa cosa succede tra due amanti (le azioni poste in essere sono le stesse), con la differenza che il sentimento è decuplicato perché reca con sé un’intensità maggiore e un maggiore trasporto (ecco spiegato il senso del ti amo invece del ti voglio bene).
E perché non anche con un gatto, un cane, un canarino o un cavallo a cui ci si affeziona più di quanto non succede tra esseri della stessa specie? (Ah, mio caro Snoopy…!).
Occuparsi di loro (in quanto persone e in quanto animali), dedicare loro del tempo e attenzioni non è forse una forma di affetto?
San Valentino sarà pure il patrono degli innamorati, ma se siamo tutti in amore – adesso chi più chi meno, chi in poca o egual misura non stiamo a questionare – perché escludere dai festeggiamenti chi non ha un compagno o una compagna?
San Valentino è una festa stupida, ed è stupida per il motivo di cui dicevo prima: a voi serve un giorno per far vedere a una persona quanto le volete bene, oppure una vita è troppo poca? Cosa fate il giorno dopo? Vi snobbate, vi prendete a calci e pugni, non leggete più i messaggi sul telefono, liquidate tutto con un “ora ho da fare, non ho tempo di stare appresso a te”? Oppure continuate a perseverare, a dedicarvi ad esso, a coltivare ancora quel sentimento, ad innaffiarlo, aiutandolo a farlo diventare sempre più bello e rigoglioso?
Anche l’8 marzo è una festa stupida (ma che festa è? Cosa si festeggia?). Negli ultimi anni ha acquisito più risalto perché sembra – e sottolineo sembra, perché le apparenze sono sempre in vantaggio rispetto alle verità – ci sia più un occhio di riguardo nei confronti della condizione della donna. Sia chiaro, l’attenzione al tema violenza o vessazione (sia fisica che psichica) sulle donne c’è, è reale: se ne parla, se ne scrive, se ne discute, si battaglia per il riconoscimento dei diritti in campo sociale, lavorativo, sull’uso che posso fare del mio corpo, se dare l’utero “in affitto”, se voglio ingrassare, se voglio fare la escort per mia libera scelta senza per questo essere giudicata (per chi vuole approfondire quest’ultimo argomento si consiglia il testo di Valentina Pazé, Libertà in vendita. Il corpo fra scelta e mercato per Bollati e Boringhieri recensito sulle pagine di Leggere:Tutti), ma la strada da fare è ancora lunga, ed è una strada ripida e sterrata. Serve un cambio di rotta universale che richiede il contributo e lo sforzo ci ciascuno di noi, una collaborazione paritaria tra uomo e donna, un’apertura mentale da parte dell’uno e dell’altra che appiani le “differenze” a cui ci hanno abituato da secoli (per inciso: le uniche differenze sono solo quelle anatomiche, il resto non ha nulla di anomalo o impossibile che non va o che rende un individuo inferiore o superiore all’altro. È una concezione sbagliata che è diventata “norma” perché è stata tramandata per così tanto tempo che è diventata consuetudine concepirla così; la scienza, anzi, dimostra il contrario¹).
Per tornare alle feste, trovo che tutto ciò sia molto insensato anche qualora volessimo estendere il discorso sulla festa del papà e sulla festa della mamma (e su quella dei nonni). Se proprio avete tutta questa necessità di festeggiare allora fatelo il giorno stesso in cui diventate papà, mamma, nonno o nonna, senza dipendere da una data fissata in calendario. Le date servono solo per le scadenze (tasse, medicinali, cibo, prescrizioni, adempimenti burocratici). Siete scaduti voi? (Beh, alcuni sì. Scadono, ma per altre ragioni che non hanno niente a che vedere con le feste).
Cosa diversa sono gli anniversari. Gli anniversari mi piacciono di più, li sento più miei perché nessuno decide per me quando devo festeggiare. Posso far festa tutti i giorni perché sono innamorata (a proposito, quando è stata l’ultima volta che avete proferito ti amo alla vostra metà eccezion fatta per il giorno in cui vi confessaste il vostro amore? Fate i bravi, mi raccomando) perché sono mamma, perché sono nonna o perché sono donna (in quest’ultimo caso non ho nulla da festeggiare, ho solo da combattere tutti i giorni dell’anno); oppure posso scegliere di non festeggiare.
Posso scegliere di regalare qualcosa a un amico/amica, a un parente, a una maestra, a un conoscente, senza attendere il giorno del suo compleanno se mi sento di farlo e mi fa piacere farlo. A che servono ‘ste feste se non per business? (Se a Natale non ve voijo fa’ i regali perché devo essere costretta a favve i regali, se po’ sape’?)
Una foto, un’immagine, una cartolina, un disegno dice tanto. Reca con sé emozioni, pensieri, usi, giudizi, considerazioni, domande, dubbi, fantasie.
“Ma oggi non è il 14 febbraio!” dice lei. L’esclamazione è un chiaro segno di quanto un certo modo di pensare condizioni i nostri pensieri, il nostro modo di essere e le nostre vite. Lui le ha portato dei fiori e, porgendole il mazzo, le risponde “non era il 14 febbraio neanche quando io mi sono innamorato di te”, osservazione che denota quanto il nostro cervello si sia assuefatto a certe ricorrenze e a certe abitudini perché così ci sono state inculcate (e che riassume quanto abbiamo detto sinora).
Anche quell’io, ponendolo come fosse un accento sulla frase – quando io mi sono innamorato di te che è diverso da quando mi sono innamorato di te – rimarca una esclusività, un anticonformismo, una alternativaallo status quo da cui è diventato sempre più difficile affrancarsi.
¹ Si consiglia il testo di Marco Pacori, I segreti del linguaggio del corpo Sperling&Kupfer Editore 2019 – collana Pickwick
Accedi o Registrati per commentare l'articolo