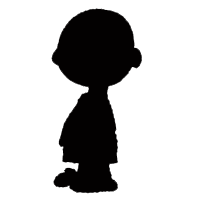
Charlie Brown
"Solo gli imbecilli non hanno dubbi"
"Ne sei sicuro ?"
"Non ho alcun dubbio!"
(Luciano De Crescenzo)
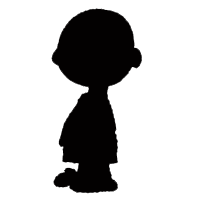
Charlie Brown
"Solo gli imbecilli non hanno dubbi"
"Ne sei sicuro ?"
"Non ho alcun dubbio!"
(Luciano De Crescenzo)
Marzo 1885. Ospedale di Salpêtrière a Parigi. Un manicomio femminile dove vengono relegate donne ritenute scomode più che pazze: prostitute, mogli, compagne che hanno ucciso i propri mariti o amanti, sovversive, anticonformiste; insomma donne ribelli e pericolose impossibili da gestire, rifiutate e dimenticate dalle famiglie, date alle “cure” dei medici e degli infermieri del dottor Charcot che presiede il nosocomio.
Dal Salpêtrière si entra e non si esce, tranne in rarissimi casi.
Tra le internate ci sono Thérèse, la decana delle alienate, un donnone ed ex prostituta che se ne sta tutto il giorno a lavorare a maglia coi ferri e a dispensare consigli alle altre degenti. Più saggia che pazza, Thérèse viene vista come una mamma – rinchiusa in manicomio per aver gettato il suo amante nella Senna –, tutto quello che avviene nell’istituto non sfugge al suo occhio vigile, ha sempre una buona parola per tutte ed ha un buon rapporto con le infermiere e gli infermieri.
Soggette a crisi isteriche, il più delle volte indotte durante le ore di lezione dall’équipe dei medici per i loro esperimenti e gli studi sulle poverette, sono tutte le altre internate. Tra queste c’è Louise, un’adolescente bandita dalla sua famiglia per tristi e sfortunate vicissitudini che continuano a perseguitarla anche all’interno dell’ospedale, dove è oggetto di attenzioni di Jules uno degli infermieri.
A capo del reparto c’è l’Anziana, ovvero Geneviève, un’infermiera che ha immolato la propria vita alla carriera di medico e con un lutto alle spalle che non è riuscita del tutto ad elaborare. Sua sorella Blandine è morta quando era ancora troppo giovane, dopo il trauma non più scomparso si è imposta di vivere con un certo rigore, atteggiamento che ha deciso di adottare anche col suo lavoro e col suo rapporto con le internate, perennemente sotto la sua osservazione.
Le giornate trascorrono tutte uguali tra passeggiate nel parco, pulizie dei luoghi comuni, rifacimento dei letti, esperimenti, veglie, dormite, pasti; l’unica iniziativa che concede alle donne un po’ di svago e serenità è il ballo di mezza quaresima che si svolge ogni anno al nosocomio, una vera e propria festa in maschera dove viene invitata tutta la Parigi bene, ossia un’occasione che consente di mischiare la borghesia con le alienate e di poter assistere anche agli esperimenti che vengono praticati nell’istituto. L’eccitazione per il ballo riempie le stanze e i corridoi le settimane prossime alla festa, alle internate viene data la possibilità di scelta dei costumi e di apportarvi anche modifiche con il ricamo e il cucito.
L’arrivo non previsto tra le alienate è quello di Eugénie Cléry, una ragazza di buona famiglia internata dal padre dopo che è stato messo al corrente che la stessa vede e parla con i defunti. L’Anziana delle infermiere, così come Thérèse, si accorge subito che Eugénie non è come le altre, la ragazza ne dà prova anche durante una lezione dimostrando di saper fronteggiare il gruppo dei luminari confutando le loro teorie. Sarà la stessa Eugénie ad aprire gli occhi all’Anziana, adusa ad assecondare le regole mediche ed “etiche” dell’ospedale – una linea di condotta e di pensiero che si allinea con quella del padre, medico neurologo ormai in pensione – a sconvolgerne le sorti e a costringerla a rivedere le sue convinzioni modellate su falsi giudizi atte a concepire la società come una realtà guidata e creata da soli uomini, che ne determinano le leggi e il destino.
Collera. Una rabbia intensa. È questo il sentimento che ha mi ha predominata durante la lettura di questo libro. Sentirmi addosso pesanti catene che lottavano per cambiare e modificare la mia natura perché mi impedivano di fare e dire quel che l’animo mi dettava di fare. Una sensazione orribile, che è poi la sensazione che accompagna ciascuno di noi, sempre: parlare o agire in un determinato modo e non venire compresi, solo perché io non vedo le cose come le vedi tu. Allora sei strana o strano. Peggio: sei pazzo o pazza. Perché non fai le cose come tutti gli altri. Perché non ti adegui, perché è così che stanno le cose e tu, che sei diverso o diversa, sei fuori dal mondo (visto? Non occorre essere uomo o donna per vivere le stesse situazioni o gli stessi stati d’animo).
Del ballo del titolo in copertina v’è spiraglio solo nell’ultimo capitolo del libro, le pagine che lo precedono sono il pretesto per poter raccontare la condizione femminile dell’Ottocento (non molto dissimile dai giorni nostri con qualche passo più avanti). Le donne erano meno di niente, un oggetto, un ornamento, una dote. Si doveva stare al proprio posto, non farsi venire idee strane, non esprimere opinioni, non andare contro la propria famiglia. Anche se erano le convinzioni di quest’ultima ad essere completamente sbagliate. Chi rovesciava l’ordine delle cose era ritenuta pazza.
Quest’uso retrogrado del pensiero lo ritroviamo, seppur in maniera sottile, in ogni aspetto del quotidiano. Non ce ne accorgiamo perché siamo molto bravi a mascherarlo (ps: il termine non è puramente casuale come ogni cosa che scrivo o parola che adopero).
Facciamo finta di essere interessati all’argomento “condizione femminile”, “parità dei sessi”, “no violenza sulle donne”, ma ne siamo spaventati. Anche quegli uomini che si schierano contro il pensiero conservatore fanno fatica ad accettare che non esiste una diversità tra donna e maschio. Ne sono consapevoli (e questo è già tanto), lavorano sul proprio Io interiore per cambiare lo stato delle cose (e li ringraziamo), ma nella rete dei loro discorsi, vuoi o non vuoi (fateci caso), resta sempre aggrappato un residuo di tutte quelle convenzioni che si sono cristallizzate nei secoli (sono secoli, purtroppo! È questo gioca molto, molto a sfavore).
Non voglio soffermarmi sempre sullo stesso argomento, penso che sia giusto parlarne ma penso sia anche giusto non eccedere o farlo senza esasperare troppo gli animi, col rischio di sortire effetti avversi e indesiderati. La questione che mi preme far capire è che qui non si tratta di essere superiori o inferiori a qualcuno, ma che siamo tutti uguali. E non è un discorso da intellettuali, non ha nulla a che vedere con schieramenti politici di destra o sinistra, o un conformarsi all’opinione comune (pure perché se c’è qualcosa a cui conformarsi la sottoscritta non si conforma a nessuno, è abituata a pensare di testa sua senza farsi condizionare dal primo o dalla prima che passa).
È ragionare usando la logica. Sono un essere umano anch’io, con desideri, passioni, rancori, dolori, stizze, bisogni. Voglio essere vista e riconosciuta per quello che sono (per chi sono, non per cosa sono). Non sono un nemico. Se mi vedi come nemico è perché sei abituato a concepirmi e a vedermi come nemico. È un tuo pre-giudizio. Sei tu il tuo nemico, il rivale di te stesso (nell’istante in cui fai germogliare questo tuo pensiero stai creando anche il tuo avversario che ti impedisce di mettere a fuoco quello che hai davanti agli occhi).
Rifletti prima di agire o di parlare. Guarda. Osserva.
È solo usando correttamente la testa che mostrerai la tua superiorità.
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Ricordati il tempo fra le vignette, è lì che succedono le cose importanti. (Gianrico Carofiglio)
Un libro. Le pagine. La scrittura, i paragrafi, la punteggiatura. L’armonia dello spazio bianco e lo spazio scuro.
E poi c’è il titolo, il sottotitolo e una fotografia in copertina. Una donna, in primo piano, e un uomo al suo fianco che la osserva ma non la tocca. Lo spazio. Il tempo. In bianco e in nero.
Ora immaginate la storia di questi due personaggi, a cominciare dal titolo. La carezza, una storia perfetta.
Non è una storia, ma una carezza. Non è (soltanto) carezza, ma (anche) storia.
La carezza è Pietro Pontani, un professore di filologia il cui sguardo incontra per caso quello di Lea Levi, ricercatrice universitaria di paleografia, durante un convegno a Rossano, in Calabria, dedicato al Codex Purpureus Rossanensis, un manoscritto bizantino. Sia Pietro che Lea sono ambedue sposati, ma subito scatta un’attrazione reciproca che li porta a trascorrere una notte d’amore, che non sarà l’unica. Da lì sino ad un tempo infinito, o “in un infinito altrove” come preferisce definirlo l’autrice, continueranno ad amarsi sino oltre l’eternità, oltre il tempo, oltre ogni sospensione e stupore. Il sentimento non divampa all’istante, cresce negli anni e nella distanza che li separa sino al nuovo incontro stabilito dalle coincidenze e dal destino. La prima volta succede nel 1999, la seconda volta nel 2019. C’è un prima, e c’è un dopo. In mezzo il tempo non esiste. Perché in mezzo ci sono Pietro e Lea.
Quella che sembra una notte di passione, in realtà, è una storia d’amore che si scrive da sola, e a scriverla sono i corpi, i baci, i sospiri, lo stupore, le carezze. Negli abbracci, nel gesto di toccarsi, Lea e Pietro annullano il tempo, lo spazio, persino quello che occupa i propri corpi stando incollati l’una all’altro, questo stare “dentro di te e fuori di me”. È una storia senza le virgole, i punti interrogativi, i punti esclamativi, le parentesi, i paragrafi, il virgolettato, le postille, i capitoli; è un unicum nero, clandestino, una scrittura priva di spazi, di respiro, di pensieri, legata a poche parole che si ripetono come i gesti, ma non per questo noiosi e incapaci di sorprendere.
È uno spazio essenziale. Lea e Pietro nel prima, nel dopo e nella distanza che è solo distanza fisica dei vent’anni, impareranno ad amarsi senza saperlo e senza mai dirselo a voce. “Ti voglio bene” è tutto quello che sa Lea quando si rivolge a Pietro, dopo l’amore. Di lui non conosce nulla, è un estraneo per lei, come lei per lui. Non sanno niente e sanno tutto Pietro e Lea dell’uno e dell’altra. Perché non è la parola che conta, le abitudini, i gusti, ma il sentimento che solo i loro corpi sanno esprimere quando sono insieme, quando sono l’una nelle braccia dell’altro, quando uno è dentro l’altra. “Fermati, aspetta”, le dice Pietro. C’è tempo. Qui, in questa stanza d’albergo, in questo spazio, c’è tutto il tempo del mondo. Non sono più me perché sono fuori da me, non sono più me e lo sono più che mai quando sono con te.
La mia lacuna sei tu, adesso.
Il mio spazio bianco.
E tu?
Non c’è una storia fuori da Pietro e Lea. I vent’anni che trascorrono senza riuscire a vedersi – per una serie di impedimenti sfortunati – sono la “lacuna”, “lo spazio bianco”. La storia inizia, si interrompe e riprende. Il sentimento rimane uguale (lo stupore, la perfezione sta nel fatto che riesca a rimanere intatto nel tempo e nella distanza, come un romanzo che si inizia a scrivere e lo si riprende dopo anni, ma è come se lo si riprendesse dopo mezz’ora), i corpi si riconoscono anche con le strie del tempo perché hanno imparato a parlarsi da soli. I baci non sono il prologo della storia, ma l’epilogo. I preliminari non aprono, chiudono. Tutto avviene al contrario, in maniera spontanea. Con urgenza.
La carezza, una storia perfetta è il romanzo con la R maiuscola. Quello che ognuno aspetta di vivere, non di scrivere (o di leggere). È una carezza che accompagna il lettore, dall’incipit sino alla fine. È una storia che appassiona per come è scritta, per come rende pulsante l’anima tra le pagine che si susseguono, per ciò che permette di vivere e immaginare. Pochissimi libri riescono a trasmettere emozioni così forti e potenti tanto da lasciare tramortiti e affamati di passione (intesa come sofferenza e desiderio).
Nella massima in esergo si fa riferimento al tempo nelle vignette (l’autore si riferisce alle vignette dei fumetti), l’ho scelta apposta perché non c’è niente di più vero di quanto riportato nell’aforisma. Come nei fumetti, anche nei romanzi è importate “lo spazio bianco” che intercorre tra un capitolo e un altro; non è uno spazio vuoto, fermo, che “separa”, è uno spazio che segna un tempo, lo spazio dove scorre il tempo e, di conseguenza, la vita.
È una regola comune a tutti i romanzi, i fumetti e le storie in generale. Se ci pensate l’intera esistenza è composta di tanti spazi bianchi, dove talvolta i respiri si fanno più lunghi, altre volte più corti.
In questo romanzo lo spazio bianco si affaccia ovunque, ed è necessario per comprendere l’importanza del tempo, dell’amore, e di tutto quello che non si può spiegare.
Perché esistono cose nella vita che non si possono spiegare, perché è la vita stessa a non sapersi spiegare. E come la vita, alcune storie, alcuni romanzi, alcuni libri, per quanto ci si sforzi, restano e resteranno impossibili da recensire.
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Mi chiamo Pietro Gerber ma qui a Firenze, dove vivo da quando sono nato, tutti mi conoscono come l’addormentatore di bambini. Sono un ipnotista, come lo era mio padre, e con l’ipnosi aiuto i bambini a elaborare traumi e a superare paure e fobie. Non sembrerebbe, ma il mio è un mestiere pericoloso. Perché la mente dei bambini è un labirinto ed è facile smarrirsi e non riuscire più a tornare. Forse è proprio questo che sta succedendo a Matias. Ha nove anni e da tempo ha un sogno ricorrente. Da troppo tempo. Ormai Matias ha paura di addormentarsi, perché in sogno gli fa visita qualcuno che non dovrebbe esistere. Una donna dall’aria triste e vestita sempre di scuro e che non parla mai. La signora silenziosa abita i suoi sogni come uno spettro, come una presenza inquietante che tracima nella realtà. Non dovrebbe essere nient’altro che un sogno, ma allora… Allora perché sento che la signora silenziosa è reale? Allora perché sento nel silenzio il ronzio di un immenso sciame di insetti? Allora perché sento che perfino la mia casa, vuota e solitaria, è infestata da fantasmi? E se la storia della signora silenziosa fosse ancora tutta da scrivere… Come la mia?
Mi chiamo Pietro Gerber, sono l’addormentatore di bambini, e di colpo ho paura di dormire. E ho ancora più paura di stare sveglio.
Questa è la storia di Matias Craveri che, da quanto si evince dalla seconda di copertina del romanzo, ha nove anni ed è tormentato da un incubo ricorrente. Da otto mesi nel suo sonno viene a fargli visita una signora vestita tutta di nero. La donna non parla, non gli fa alcun male; è molto triste e sente il bisogno di raccontargli una storia. Ma forse Matias la sua storia la conosce già.
Questa è la storia di Pietro Gerber, noto come l’addormentatore di bambini, al quale in passato molti genitori hanno affidato dei casi senza via d’uscita. Lui è la loro unica salvezza, l’unica speranza, l’ultimo tentativo che a loro resta per la salvaguardia dei loro cuccioli. Si occupa di estrarre dal loro inconscio ciò che più li spaventa, li angoscia, i mostri e i fantasmi che condizionano la loro vita e che si alimentano attraverso i loro sogni infettando la loro innocenza. È un lavoro di grossa responsabilità. Pietro sa che non sempre può riuscire a salvarli, ma c’è un rischio peggiore: quello di essere coinvolto nel loro mondo onirico e di rimanerne intrappolato. Dovrebbe essere abituato, avere il giusto distacco da ciò che ascolta e da ciò che lo circonda, dovrebbe conoscere quali sono le insidie visto che il signor B., suo padre, esercitava il suo stesso mestiere e lo portava ad essere sempre in contatto con i fantasmi altrui. Eppure, improvvisamente, anche Pietro comincia ad aver paura. Non riesce più a dormire. Ha paura di crollare, ha paura di stare sveglio. Non riesce più a capire dove finisce il confine della realtà con quello dei sogni, ammesso che esista un confine. Non sa se il silenzio da cui viene assalito quando entra in casa sua sia l’ombra dei suoi piccoli pazienti, oppure se a parlargli sia la sua ombra.
Questa è la storia della signora silenziosa di cui non si conosce il nome né il volto, solo la sua espressione che racconta di un vissuto sempre uguale. La signora silenziosa è una donna, abita i sogni di un bambino, un bambino a cui s’aggrappa per sopravvivere, per non essere dimenticata, un bambino per cui urlare. Matias si sveglia angosciato ogni volta che la vede, talvolta urla; dal loro primo incontro ha cominciato a spegnersi, appassendo come fanno i fiori. Non c’è più tempo, confessano Ivo e Susana Craveri a Pietro Gerber, bisogna far presto. Non c’è più tempo per chi, per Matias o per la signora silenziosa? Ma, soprattutto, la signora silenziosa esiste oppure è solo la visione di un bambino?
Questa è la storia di un silenzio, che non dice nulla ma ha tanto da raccontare.
È la storia di tre persone, quattro, sei, dieci e così via.
La casa dei silenzi è il nuovo, ipnotico, sconvolgente e mesto thriller di Donato Carrisi dove a essere in gioco, questa volta, non è solo la felicità e la libertà di un bambino.
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Ci sono libri che ti accompagnano per tutta la vita, che anche quando hai finito di leggerli ti restano addosso per sempre.
All’inizio non lo sai, non te ne accorgi, l’incontro avviene casualmente, inconsapevolmente, un po’ come quando ha inizio una storia d’amore che non sai dove ti porterà.
A me è successo con Il compagno proibito di Sauro Marianelli. L’ho conosciuto a undici anni sui banchi di scuola, ed è stato il colpo di fulmine.
Si chiama Goro. Ha all’incirca 13/14 anni (oggi può averne venti, quaranta, sessanta, novanta – al termine della recensione verrà svelato il mistero) in realtà nessuno sa quanti anni ha perché nessuno sa da dove viene, chi sono i suoi genitori, dove abita, cosa studia, se lavora e che lavoro fa.
Intermezzo: ho scritto in realtà perché nella realtà Goro non esiste come tutti i personaggi della letteratura; in questo caso però non mi riferisco solo alla realtà concreta, ma anche alla realtà del romanzo: di Goro nessuno sa niente. È come se non esistesse, i ragazzi della sua età si tengono alla larga da lui, uniformandosi al precetto inderogabile dei genitori di non frequentarlo per nessuna ragione. Per essi Goro è il figlio del Diavolo, un ragazzo che vive per strada senza regole (da qui l’appellativo "proibito"). Eppure il ragazzo non è un molestatore anzi, sa cavarsela da solo, è in grado di gestire qualsiasi situazione autonomamente come un adulto, gira sempre con abiti puliti e in ordine, conosce tantissime cose pur se non ha mai frequentato un istituto scolastico (nonostante ciò sa anche leggere e scrivere) e non è mai stato coinvolto in risse. Ma non è nessuno, perché Goro non ha genitori, non ha amici, non ha parenti.
Damiano, anche lui adolescente, per quanto si sforzi non riesce a conseguire risultati soddisfacenti a scuola. Continuamente vessato da suo padre che lo ritiene un fannullone, il ragazzo vive un costante senso di inadeguatezza che lo porta a compiere azioni inconsuete e dagli esiti disastrosi, specialmente nelle questioni di cuore.
Con Assunta è amore a prima vista. La ragazza, figlia dell’imprenditore Toncelli, appartiene ad una buona famiglia e frequenta lo stesso istituto scolastico di Damiano (anche se classi diverse). Damiano fa di tutto per farsi notare da lei: le infila i bigliettini con scritte frasi d’amore nel cappotto, segue attività extrascolastiche nella stessa parrocchia dove la ragazza fa catechismo, le versa addosso l’acqua santiera – rischiando grosso col padre di costei che la accompagna sempre in macchina sia a scuola sia in chiesa – fa il finto bulletto tra i compagni (finto perché non gli riesce)… il tutto senza incassare la briciola di una vittoria.
La batosta arriva quando scopre che è stato escluso dalla lista degli invitati per il compleanno di Assunta, e decide di farla finita buttandosi dal campanile della chiesa. Ha programmato tutto, ha persino scritto una lettera d’addio, quel che non ha previsto è il seguito di una storia di cui ha buttato giù solo le prime righe del prologo. A dare una svolta è infatti Goro, che lo salva appena in tempo offrendogli il riscatto tanto atteso dal destino: gli propone un viaggio che li porterà alla scoperta di una civiltà antica (quella degli Etruschi) in cambio di uno specchio che vale una fortuna. Damiano, dapprima titubante, accetta di seguirlo. Come tutti i suoi coetanei conosce Goro e sa quel che si dice in giro di lui (anche i genitori di Damiano vogliono che il figlio giri alla larga dal ragazzo), ma non è per via della reputazione di Goro se all’inizio tentenna, ma è perché non sa se fidarsi della sua promessa di lasciargli lo specchio (a sentire Goro, lui è solo interessato a diventare amico degli Etruschi, non gli importa di diventare ricco, lascia a Damiano la fama di milionario).
Il compagno proibito è un romanzo scritto per la platea di adolescenti che si compone pressappoco di duecento pagine che a loro volta suddividono il libro in quattro momenti: una prima parte dove conosciamo Damiano, la sua storia, la sua famiglia, le sue peripezie da dodicenne sfigato, una seconda parte dove Goro fa il suo ingresso nonché il preludio del viaggio che s’apprestano a compiere i due ragazzi, la terza parte relativa al viaggio vero e proprio, e la quarta parte l’epilogo che chiude il cerchio del libro.
Stupisce come una siffatta opera sia scritta – utilizzando anche dello humor – in maniera così semplice ma completa, esaltando quello che è il disagio della pubertà, ovvero la sensazione di non sentirsi mai all’altezza delle situazioni. È un libro puro, tenero, pulito, proprio come i personaggi che lo abitano, che affronta temi attuali ma in un’ottica diversa dal tempo contemporaneo che stiamo vivendo. L’autore scrisse il romanzo quando ancora non c’era internet, quando i social non esistevano, quando mancavano i cellulari, i tablet, i pc, quando la violenza non spopolava in modo così cruento e virale nelle radio e nella televisione (Il compagno proibito è un romanzo editato nel 1981 dalla Fabbri Editore reperibile nei mercatini dell’usato e tra le bancarelle dei libri oltre che online).
È un viaggio tra i pensieri, i dubbi, le emozioni, le considerazioni e le aspettative di Damiano. Non è scritto in prima persona, ma Marianelli è bravo a narrare la storia come se a raccontarla fosse proprio Damiano.
Forse perché fa parte della raccolta dei primi libri che ho letto nel corso della mia adolescenza che Il compagno proibito resta e resterà sempre, con Rebecca la prima moglie, tra i miei libri del cuore. Non sono pazza se dico che con esso mi sono innamorata per la prima volta. Goro è un personaggio straordinario (n.b: stra-ordinario, oltre l’ordinario), è stato il primo ragazzo da cui sono rimasta colpita e affascinata per la sua inesauribile sete di conoscenza, l’incontenibile curiosità verso tutto ciò che lo circonda, la sua capacità di sapersi adattare a ogni cosa, la sua intraprendenza mescolata ad un pizzico di incoscienza, la sua libertà, il suo essere altro dagli altri senza scavalcare chi è diverso da lui. Pur essendo un “emarginato” dalla società, non ha mai provato rancore o senso di vendetta nei confronti di quanti lo hanno tagliato fuori (e sono veramente tanti); lui è forte, sa di potercela fare da solo, ma non se ne fa un vanto. Diventa l’eroe di Damiano oltre che il suo salvatore e il suo mentore.
Goro è un personaggio che mi trascino dietro nel tempo. Come ho detto, l’ho conosciuto tra i banchi di scuola nell’ora di italiano riservata alla narrativa. È stato il mio primo amore, la mia prima cotta. Da allora ho costruito altre storie nel mio immaginario che avevano (e tuttora hanno) come protagonista maschile Goro. Quando devo immaginare una persona di sesso maschile, quel personaggio ha il volto di Goro. Non mi capita con i personaggi degli autori italiani o stranieri, del presente e del passato, ma solo con quelli che sbucano fuori dalla mia penna.
Forse c’è più di una ragione per cui sono portata ad associarlo con “quelli usciti di fantasia”. Chi ha avuto la fortuna di leggere questo preziosissimo libro, chi vorrà leggerlo e chi riuscirà a reperirlo scoprirà perché.
A me non resta altro da fare che tornare a trovarlo di tanto in tanto tra le scansie della libreria quando ho voglia di fargli un saluto. Perché so che non se ne è mai andato (il segreto, ripeto, sta nelle pagine del libro).
Ciao Goro.
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Fabiano Massimi è uno degli autori che bisogna leggere almeno una volta nella vita.
Non solo per lo stile adoperato nella scrittura, ma soprattutto per la sua competenza e preparazione nel saper raccontare uno dei periodi più bui e tragici della Storia, che hanno come sfondo gli anni dell’ascesa del nazismo e del fascismo. Mai come il tempo che stiamo vivendo c’è più che mai la necessità di narrare gli ignominiosi avvenimenti che si sono succeduti in quegli anni di cui, purtroppo, si ode ancora forte l’eco e i cui resti non sono stati cancellati– come si vuol credere o come si è indotti a far credere – ma, anzi sono prorompenti e rinascenti come ceneri di una fenice.
Le Furie di Venezia è il terzo libro della serie del commissario Sigfried Sauer (i primi due sono L’ Angelo di Monaco e I Demoni di Berlino) il cui plot è incentrato sulla figura di Ida Dalser, la prima legittima moglie del Duce.
Il romanzo si apre nell’anno 1934 dove rivediamo Sauer, Mutti, ovvero Helmut Forster nonché collaboratore del primo, affiancati da Sandor, un poliziotto ungherese, che si trovano a Venezia per sventare un’alleanza tra Mussolini e Hitler. I due dittatori si incontreranno a piazza San Marco in mezzo a una folla di camicie nere per sancire la coalizione tra l’Italia e la Germania. Purtroppo le cose non vanno secondo i piani prestabiliti, così i tre, aiutati da un italiano esperto nel falsificare i documenti, Livio Sarpi (che si scoprirà amico dei fascisti) escogitano un’altra occasione per fermare quella che si rivelerà negli anni una politica scellerata e sciagurata per molte vite portata avanti da un esaltato; ma è nel corso di una serata che nel “pedinare” Mussolini per la laguna di Venezia scopriranno che il Duce nasconde un segreto che, se venisse svelato, potrebbe davvero cambiare le sorti del Paese. Nell’isola di San Clemente insiste un istituto, originariamente un monastero ora un manicomio femminile, dove è rinchiusa Ida Dalser per ordine del Duce. La donna afferma di essere l’unica e la prima moglie legittima del podestà e di aver avuto dallo stesso un figlio che porta il suo stesso nome, Benito Albino Mussolini, successivamente riconosciuto dal padre. Come naturale, il Regime non vuole che la storia venga a galla, per questo motivo insabbia qualsiasi prova o documento che possa far luce su questo aspetto privato del capo del Governo. Sigfried, aiutato da Mutti, Sandor e Johanna Tegel – poliziotta innamorata di Sauer dai tempi dell’incendio del Reichstag – infiltratasi nel manicomio come infermiera, cercheranno di far evadere Ida senza successo con la promessa di evitare a Benito Albino Mussolini le stesse sorti della madre.
La seconda parte del libro si apre nel 1942. Siamo a Milano dove Fausto Armeni, commissario di polizia antifascista e amico di un giornalista del Corriere della Sera, Alberto Graf anche lui antifascista, conduce la sua vita senza tante speranze sul proprio futuro e su quello del Paese. La moglie, Margherita, è ricoverata presso un istituto psichiatrico a Mombello e Armeni non fa altro che scandire le proprie giornate dividendosi tra il lavoro e le visite alla moglie. Durante una di queste succede un fatto inaspettato quanto strano: un paziente sembra essere riuscito a sfuggire alla sorveglianza dei medici e degli infermieri. Si tratta di un ragazzo di ventisette anni che sarà lo stesso Fausto a rinvenire nascosto e mezzo svenuto tra i cespugli del parco del manicomio, un paziente su cui è puntata la massima attenzione di tutto l’istituto – primario per primo –. Il ragazzo è nientedimeno che Albino, quell’Albino, cui Sauer si era fatto carico della promessa a sua madre di risparmiargli lo stesso destino. Il commissario dai capelli biondi e gli occhi cerulei farà tappa anche a Milano dove, insieme a Fausto, a Emilia (segretaria di quest’ultimo) e ai suoi compari (Mutti e Sandor) tra mille peripezie anche qui come a Venezia, faranno di tutto per salvare la vita ad Albino.
È una sensazione strana quella con cui si resta addosso al termine della lettura dei libri di Fabiano Massimi, un’emozione (comune a tutti i suoi romanzi) che non so definire. Ha il sapore dell’amarezza, della sconfitta, dell’impotenza, ma anche della tenerezza. Non sapendo che nome dare a quest’emozione mi viene da dire solo “è molto bello”. E quando qualcosa è bello vuol dire che questo qualcosa ha lasciato un segno.
Quello di Fabiano Massimi è un genere storico, non sbaglio di molto se lo consideriamo il Ken Follett della letteratura italiana solo che, a differenza di quest’ultimo dove vengono dedicate numerose pagine alle passioni, in Massimi questo non avviene concentrato più sulle descrizioni dei luoghi, delle persone, dei fatti. Anche nelle sue opere, come Follett, i sentimenti e gli stati d’animo giocano un ruolo fondamentale, ed è altrettanto bello come riesca a far entrare in empatia il lettore col personaggio attraverso le descrizioni di ciò che rumina l’animo di un personaggio con ciò che lo circonda, sia esso un paesaggio, un oggetto o un ricordo. Sono pochi gli scrittori che riescono a fa questo, e credo che in ciò stia il segreto del successo di questo autore che si sta conquistando (meritatamente) la platea internazionale.
Più di ogni altra cosa mi è rimasta addosso la sensazione di sentirmi braccata, di avvertire il senso dominante e di oppressione del Regime, il controllo smisurato su ogni parola, ogni pensiero, ogni azione, ogni respiro, ogni battito di cuore; e mi sono domandata cos’è che spinge le persone ad osannare (e desiderare!) gente con una mentalità egocentrica, totalmente slegata dalla realtà, che non tiene conto delle esigenze del prossimo e delle diversità (da intendersi in senso lato, come moltitudine di aspetti non come limite o disabilità) e che non accetta né sopporta chi è altro da sé tanto da sopprimerlo o bandirlo.
Non sto affermando che non debbano esserci limiti, ok alle regole ed è giusto che vengano rispettate, ma in un’ottica di equilibrio e di misura senza strafare, anche per ciò che concerne la libertà di una persona.
Come è bene raccontare per non dimenticare, per meglio affrontare le problematiche in un’ottica di confronto e di condivisione senza generare caos, odio e anarchia.
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Nella foto la copertina del libro e Daphne du Maurier
“Sognai l’altra notte che ritornavo a Manderley. Mi pareva di essere al cancello che dà sul viale di ingresso, e non potevo entrare: la via era sbarrata. Una catena con un lucchetto chiudeva il cancello. In sogno chiamavo il guardiano, ma nessuno mi rispondeva, e accostandomi a guardare tra le sbarre arrugginite, mi accorgevo che la casetta era disabitata”.
Così comincia Rebecca, la prima moglie romanzo del 1938 della scrittrice inglese Daphne du Maurier, meglio nota come la musa ispiratrice di Alfred Hitchcock.
Il libro è di sicuro il capolavoro più riuscito dell’autrice, tant’è che ebbe uno strepitoso successo (fu adattato per il teatro, nel 1940 Hitchcock produsse una pellicola con Joan Fontaine e Laurence Olivier, e nel 2013 la Rai mandò in onda la fiction con Cristiana Capotondi e Alessio Boni).
A Montecarlo, durante un viaggio, una giovane donna che lavora come dama di compagnia per una vecchia signora dispotica e pettegola – che accompagna durante il soggiorno – conosce il ricco vedovo Maximilian de Winter. L’incontro avviene per caso, mentre stanno desinando nella sala ristorante dell’albergo; è la stessa signora van Hopper ad avvicinarlo e a informare la giovane dama chi è Maximilian de Winter. Fatto sta che la fanciulla (di cui non si conosce il nome perché l’autrice non lo rivelerà mai per tutto il corso del romanzo scritto in prima persona) e il facoltoso de Winter finiscono col provare attrazione l’una per l’altro, che scatena un garbato e discreto corteggiamento da parte di quest’ultimo. Quando arriva il giorno della partenza lei, sconsolata, gli comunica che deve tornare in America ed è in quel preciso istante che d’impeto lui le chiede di lasciare tutto e di seguirlo in Cornovaglia perché vuole sposarla. Lei accetta e, resa edotta la signora van Hopper che non prende affatto bene la decisione, insieme a Maximilian si trasferiscono nella tenuta di Manderley.
Tuttavia, sin dal primo momento in cui la giovane mette piede in quella che è e sarà la dimora coniugale, le cose non saranno affatto come immaginava. La sua goffaggine, la sua timidezza, la sciatteria, la giovane età, stridono con quello che è l’ambiente raffinato e di lusso di Manderley. Non ha nessuna idea di come si porta avanti una tenuta di quelle dimensioni, di come impartire gli ordini ai domestici, di come trascorrere le giornate, di come vestirsi, di come organizzare feste, ricevimenti, insomma non è assolutamente adusa alla vita di una società di un certo livello (e di una certa classe). La situazione diventa ancora più pesante con la presenza della signora Danvers in ogni angolo del maniero, di cui conosce tutte le stanze, tutti gli oggetti, tutti i ninnoli, le lenzuola, le tende, i quadri, le suppellettili, i profumi, i mobili, gli specchi, i libri, le finestre ecc. Un vero e proprio cane da guardia che darà alla giovane signora de Winter del bel filo da torcere.
La signora Danvers è la governante di Manderley e, prima ancora, era la governante nonché cameriera personale di Rebecca, la prima moglie di Maximilian morta in una tragica circostanza. Va da sé che, avendo vissuto per tanti anni accanto a Rebecca considerandola al pari di una figlia, questo secondo matrimonio del padrone non lo prende per niente bene ma, soprattutto, non accetta che il posto di Rebecca venga riempito dalla presenza di una donna di basso rango sociale, sciatta e inesperta, che non tarda a far sentire inadeguata e usurpatrice del ruolo di moglie (quasi come se essere diventata la signora de Winter fosse un vero affronto nei confronti della sua padrona).
Rebecca è bellissima. È la donna più bella mai esistita (testuali parole riferite dal cognato di Maximilian alla moglie di quest’ultimo durante una passeggiata nel giardino della tenuta), ma Rebecca è morta. La peculiarità di questo romanzo sta nel saper fare di una morta la protagonista assoluta. Rebecca è ovunque: nei dialoghi, nelle stanze di Manderley, nel cibo, nei vestiti, nel giardino, nelle rose, nelle vacanze, nelle foto, nelle abitudini e nei costumi della casa, nelle lettere… è una presenza ingombrante nel senso vero e proprio della parola. La du Maurier la fa pesare questa cosa, fa sentire l’ombra costante di Rebecca, la sottolinea, ne fa parlare in continuazione i personaggi, anche il cane ne sente la mancanza (è difficile farlo schiodare dall’angolo vicino al camino per fargli sgranchire le zampe all’aria aperta, conosce i passi di Rebecca, di conseguenza non si alza più, e chiunque entri nel salone manco ci fa caso).
Il personaggio di Rebecca è molto particolare, affascina non solo per la sua bellezza e per le sue competenze di gran donna e padrona di casa, ma anche per il suo mistero. Tutti ne parlano bene e chi non ne parla – o non ne vuole parlare – si chiude in un ostinato silenzio che dice più delle parole. Il confronto con la prima moglie è all’ordine del giorno. Non è solo la signora Danvers ad affondare il dito nella piaga ma pure il resto della servitù, la sorella di Maximilian, il di lei marito, Jack Favell (cugino di Rebecca) e Ben (figura molto interessante che è la chiave di volta della storia), lo scemo che bazzica nei pressi della costa del mare (Manderley è situato poco lontano dal mare).
È un testo cupo, una favola nera (perché, analizzando la storia, di una favola si tratta) che gioca molto sulla psicologia dei personaggi (sulla scia dei gialli di Simenon) tutti ben cesellati tanto da ricordare benissimo anche quelli che stanno lì solo come comparsa.
È un libro che lessi quando avevo 13 anni (quello che resta il mio libro preferito nonostante nel corso del tempo ne ho letti tantissimi) ma posso dire che i personaggi li ricordo tutti, come ricordo la loro caratterizzazione per via di alcune scene che mi sono rimaste impresse nella mente; ad esempio quella della signora van Hopper che si insudicia il viso di sugo mentre se ne sta seduta a pranzare nonostante abbia legato al collo un fazzoletto, la figura nera della signora Danvers che si stacca dalla fila degli inservienti quando Maximilian e la moglie fanno ritorno a casa dal viaggio di nozze per le dovute presentazioni, la calligrafia elegante di Rebecca che firma con una R slanciata e un po' obliqua, o ancora la macchia scura del tappeto che la signora de Winter nota sotto i piedi nell’aula di tribunale (ok, vi ho fornito abbastanza elementi per farvi venire la curiosità e leggerlo? Non rimarrete delusi, ve lo assicuro).
Che poi, un occhio attento si accorge subito che già l’incipit rivela su che registro viaggia l’opera, “Mi pareva di essere al cancello che dà sul viale di ingresso, e non potevo entrare: la via era sbarrata”. “La via era sbarrata”, alias “Tu qua non puoi entrare”. “In sogno chiamavo il guardiano, ma nessuno mi rispondeva”, “Tu non esisti perché non fai parte di questo ambiente, tu non sei e non sarai mai come Rebecca”.
Ma allora perché un uomo di una certa età, vedovo, ricco, che gode di una grande reputazione, che aveva una moglie bellissima di cui, a detta di chi gli gira intorno e lo conosce, era innamoratissimo, di cui sente la mancanza, vive nel suo ricordo, si prende la briga di sposare una giovane donna che è tutto l’opposto della prima moglie fregandosene di quello che possano pensare o dire gli altri?
Cosa c’è sotto? Cos’è che stona?
Il libro parte lento, è molto descrittivo e minuzioso nei passaggi da una scena ad un’altra (come se si assistesse ad una pellicola di Stanley Kubrick), rammento che anni fa, quando lo lessi, lo abbandonai per qualche settimana perché dapprincipio non riusciva a coinvolgermi per il suo essere pedante nelle descrizioni. Quando lo ripresi non riuscii più a fermarmi tanto che lo ricordo (e lo rileggo molto volentieri) ancora oggi.
Rebecca non è solo il mio libro preferito, è anche la mia password.
Post scriptum: ora recatevi in banca e svaligiate la mia cassetta di sicurezza.
Accedi o Registrati per commentare l'articolo